Interview | Antonio Prete
Parliamo del dialogo, inteso anche come figura filosofica ed euristica. Mi sembra che nella sua prassi di scrittore ed ermeneuta il dialogo sia realtà vivente e mai finzione retorica, pretesto disatteso, come troppo spesso avviene in gran parte del mondo comunicativo postmoderno…
Sì, penso che il dialogo sia anzitutto un fatto interiore: dialoghiamo con noi stessi, con il nostro passato, con le figure che vengono a noi da un tempo già chiuso, già fatto cenere, da un tempo di per sé irreversibile e che grazie al nostro interrogare torna a rivivere. E dialoghiamo con gli autori, con i loro libri: mi accade spesso di pensare alla Biblioteca, soprattutto ai classici, come a uno spazio dove i dialoghi si intrecciano, e tuttavia non c’è un vociare, ma il silenzio della riflessione, il silenzio del sapere che ogni volta si fa condivisione, si fa presenza condivisa. La conversazione con i classici: quella che chiamiamo critica non è altro, per me. Se poi questa conversazione la immaginiamo come rapporto tra testo e interprete, come reciproco domandarsi del testo e dell’interprete, come lingua e pensiero e giudizio che cresce nell’incontro e cerca la scrittura come tempo – spazio del suo inveramento, della sua visibilità – ecco allora che siamo nell’ermeneutica. Quanto al dialogo, m’è accaduto di tradurre nel corso degli anni Ottanta Le Livre du Dialogue, di Edmond Jabès. Lo traducevo anche dialogando concretamente con l’autore. Sia negli incontri amicali sia nell’esercizio della traduzione sperimentavo quello che Jabès dice. Che cioè il vero dialogo comincia dopo il dialogo, insomma c’è un après-dialogue, un dopodialogo, che si chiude nel silenzio della distanza, nella solitudine che segue all’incontro esteriore.

Il fatto che la sua ermeneutica instauri sempre un rapporto dialogico con la testualità, presuppone che ogni ermeneutica sia inevitabilmente dialogica? In altre parole si dà ermeneutica fuori dal rapporto con l’alterità?
Certo, ogni ermeneutica è dialogica, è cioè fondata sul domandare e sulla reciprocità: il testo si fa vivente e interrogante, e l’interprete vive in questa relazione, trasferisce in questa relazione, in questo domandare, parte della sua esperienza di vita. Questo era il senso dell’antica esegesi: da ex- ago, metto in azione, metto in movimento, traggo da…: non c’era esegesi laddove il testo non era interrogato a partire dalla propria vita, laddove la lettura del testo non aveva a che fare con scelte della propria esistenza. Questa idea, soprattutto patristica, dell’esegesi antica e medievale (è nell’interpretazione del testo sacro che si forma l’ermeneutica), per me è un passaggio importante per orientare la critica. Naturalmente sapendo che al testo sacro s’è sostituito il testo profano: ma in questa sostituzione in certo modo, l’abito dell’interprete, la sua disposizione interrogativa e coinvolgente, non sono mutati. È quello poi che intendeva Walter Benjamin quando parlava del rapporto tra critica e verità. Ma per me a questa disposizione, si è aggiunta un’idea baudelairiana della critica, una sorta di “dover essere” della critica: la critica che deve essere “appassionata, politica, parziale, cioè fatta da un solo punto di vista, ma tale che possa aprire il massimo di orizzonti”.
Mi chiede se c’è ermeneutica senza rapporto con l’alterità. Direi di no: sia perché il testo è l’altro, cioè la differenza, sia perché al di là del testo e dell’interprete c’è ancora l’altro come scrittura, come luogo dove l’esperienza del rapporto si mette in scena, si racconta, si comunica a un “altro” lettore. È su questo terzo momento che, per quanto mi riguarda, consiste l’identità propria della critica, il suo stile. Per questo mi è accaduto spesso di interrogarmi sullo stile della critica, sul come scrivere del critico. Da qui il mio sospetto nei confronti della critica axiologica, classificatoria, giudicante. Da qui la mia preoccupazione che la critica sia scrittura, viva nella scrittura.
Mi piacerebbe ascoltarla sul Pensiero poetante, sul pensare, conoscere per metafore. Sentire nel tono confidenziale di una conversazione gli esiti che su di lei ha avuto questa scoperta, quanto questa viva anche nell’azione della scrittura creativa…
Dando al mio studio sullo Zibaldone leopardiano il titolo Il pensiero poetante intendevo solo dare rilievo, certo in polemica con la critica leopardiana come fino allora si era configurata, a quella tensione davvero forte, esistente nel pensiero di Leopardi verso un dialogo, se non verso un’unità, tra filosofia e poesia. Pulsione che da una parte aveva in sé il riverbero dell’antica sapienza greca, dall’altra la consapevolezza che nel moderno la separazione tra una filosofia ragionevole e una poesia anche essa però considerata ragionevole o artificiale, insomma impastoiata nella convenzione delle forme, e dei metri, e dei pensieri, era una divisione da superare. Per un rapporto nuovo tra una nuova filosofia e una nuova poesia (una poesia del sentire e del patire). Questa tensione tra filosofia e poesia, questa pulsione mi sembrava il punto che poteva anche permettere di vedere lo Zibaldone, le Operette, i Canti in stretto rapporto tra di loro: tutta la scrittura leopardiana mi appariva, e mi appare, attraversata da un pensiero poetante. Ma la sua domanda va oltre. E allora dirò che in realtà quell’espressione, sottratta la sua origine, è divenuta per me come un’impresa e un invito: scrivere e dare forma a un pensiero poetante. A un pensiero che prenda dalla poesia il senso dell’oltre, dell’incompiuto, del necessario, del ritmo, del rapporto tra suono e senso, della modulazione sonora dell’idea. Non so, potrebbe anche essere qui, in questa idea di pensiero poetante, la radice del mio interesse non per un genere specifico della scrittura ma per il riverbero di un genere nell’altro, Per lo slittamento di un genere nell’altro: poesia, saggio, narrazione non sono per me, non devono essere, mondi separati, né pratiche separate.
Aver associato il lavoro di ermeneuta a quello di comparatista e traduttore è stato il risultato destinale dell’interpretazione in ascolto e in interrogazione? Ovvero, al contrario, è stato il traduttore e il comparatista a disporsi su di un asse di ermeneutica aperta?
Non saprei: indubbiamente in tutto quello che cerchiamo di fare c’è come una circolazione di forme, un rispondersi delle forme e dei modi. Insomma c’è una correspondance come nella natura così nei linguaggi che adoperiamo. Il comparatismo non l’ho mai vissuto in senso disciplinare, pur essendo stato tra i primi ad aver insegnato in Italia questa disciplina, dopo la sua sparizione voluta dalla vecchia riforma gentile. La mia formazione universitaria e postuniversitaria è stata molto poco lineare, muovendosi tra attenzioni filosofiche e passioni letterarie, tra esercizio della scrittura in proprio e piacere della lettura, certo disordinata, dei classici: forse per questo a un certo punto mi è sembrato che la letteratura comparata potesse raccogliere l’erranza, per così dire, cioè unire i miei interessi per la letteratura francese e per quella italiana, ma anche per le altre letterature. E soprattutto rispondere a quel certo incantamento e a quella grande curiosità che fin da ragazzo provavo per le lingue e culture lontane. Mi ha sempre colpito il fatto che la bellezza delle lingue stia nella loro pluralità, dove sta però anche la loro parzialità, la loro distanza irreversibile da una lingua unica, originaria, perduta, e forse mai esistita. Nelle lingue c’è il fascino della lontananza, ma anche della alterità nei confronti del materno, della lingua materna. La frequentazione delle altre letterature è inevitabile che prima o poi induca alla traduzione: è traducendo che davvero l’altra lingua da straniera si fa prossima, da differente entra in dialogo con noi, fino a spingerci alla sfida estrema, che è quella del tradurre la poesia, dove è sempre un azzardo che bisogna tentare: spogliare il poeta straniero della sua lingua, che è il suo paese, quello che egli ha di più proprio in quanto poeta, e ospitarlo nella casa della propria lingua. Come questo possa avvenire lasciando che l’altro conservi il suo timbro, la sua identità, la sua voce è il miracolo della traduzione. Penso che ogni comparatista debba essere un traduttore, anzitutto. Cioè mettersi in stato di ascolto nei confronti dell’altro E quale disposizione all’ascolto e più accorta e assidua di quella che il traduttore deve possedere?
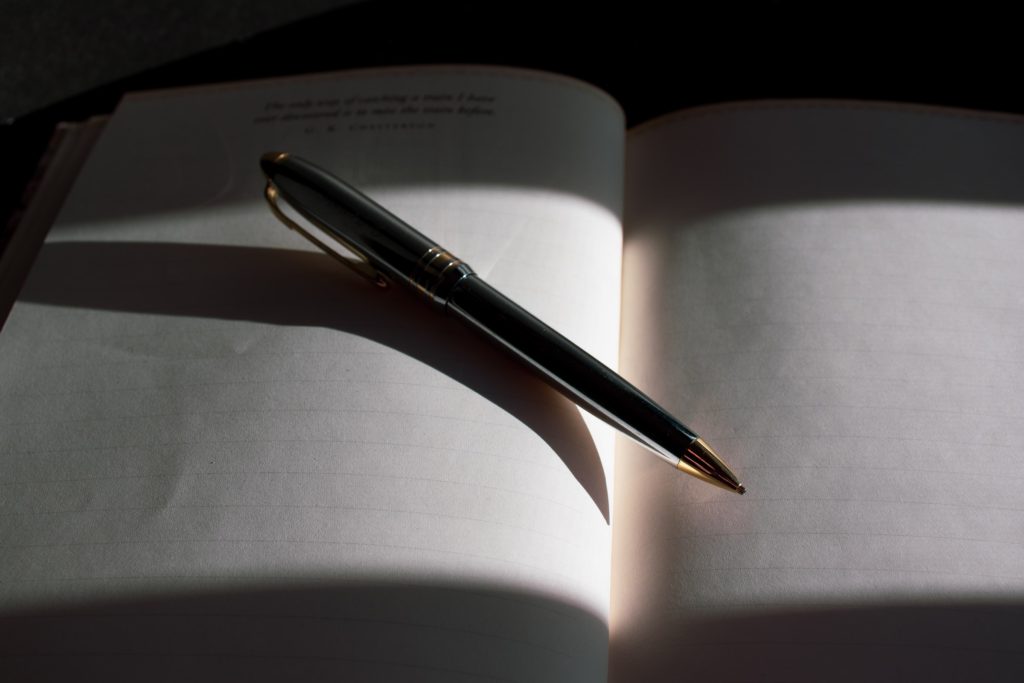
Come pochi, lei ha illustrato il sentimento della nostalgia, riconoscendolo peculiare alla poesia e al suo linguaggio. Mi parla del suo personale rapporto con questo sentimento? Se le fa piacere, anche, delle figure del suo passato: la madre, I luoghi, gli archetipi, le atmosfere…
Mi sono occupato della nostalgia, perché mi aveva da tempo incuriosito il fatto che la parola nostalgia fosse una parola moderna, coniata nel 1688 dal giovane Johannes Hofer. Costui doveva dare un titolo latino alla sua dissertazione medica che si occupava della malattia detta Heimweh, doveva insomma classificare clinicamente una malattia che colpiva in particolare i soldati svizzeri quando questi erano di stanza in guarnigioni straniere. Alla biblioteca dell’Università di Basilea andai a cercare la dissertazione. Così pubblicai la dissertazione con un’introduzione e una antologia di testi che raccontavano il passaggio della nostalgia da malattia a sentimento. Certo, potrei chiedermi perché ero così interessato alla storia clinica e letteraria della nostalgia. Potrei forse rispondere che mi sembrava un fenomeno analogo, per suo svolgimento storico, all’antica melancholia. O anche potrei dire che dal punto di vista della scrittura mi colpivano i meccanismi del ricordare, della leopardiana ricordanza, e soprattutto mi interessava il rapporto con la temporalità, le sue figure, le sue rappresentazioni. Come il ricordare si fa forma, cerca un ritmo, si fa lingua poetica. Quanto al mio personale, e intimo, rapporto con il rammemorare, o con la nostalgia, dovrei dire che di fatto a me piace non dimenticare, insomma mettere in atto modi della fantasia, e del linguaggio, e della comunicazione, per resistere all’oblio. Così, pur sapendo che ogni ritorno al tempo già passato è impossibile, mi piace raccogliere da quel tempo passato le immagini, oppure ritagliare, in quell’impossibile ritorno, piccole possibili finzioni di ritorno: rivedere certi luoghi, ritrovare certi amici. Ho anche conosciuto, come tutti, il il dolore di certe separazioni. Ma il non vedere più, o non poter vedere o non riuscire a vedere una persona, sento che è una spina e che mi dà più di una puntura. Per questo forse soffro gli adii, e appena possibile tento i ritorni. Quanto all’immagine di mia madre, ecco, qui dovrei aprire un altro discorso: tutto relativo alla sua centralità e presenza nel mio modo d’essere, oltre che all’assiduità del ricordo. Ma qui forse entriamo nella scrittura: è lì che sento operare questa presenza. Come non so. È forse questione di uno sguardo sul mondo, o di un senso estetico delle cose, o di un modo di raccontare, o di una forma di dolcezza che diventava pensiero sulle cose…

Sarebbe interessante avere una sua lettura sul destino della poesia e della prosa nell’epoca a noi contemporanea.
È difficile dirlo. Certo, i segnali, dal punto di vista della lettura, della sua diffusione, non sono lusinghieri. C’è una dominanza mercantile dei generi, dei libri di genere, che attingono a un immaginario mediato dal mass-media. Da qui il conformarsi e adeguarsi dell’editoria, soprattutto della grande editoria, a questi meccanismi di produzione. Quel che è televisivamente omologabile, o già omologato, o riferibile al mercato delle immagini condotto dalla televisione, ha accesso facile nell’editoria meglio distribuita. Insomma i grandi editori sono sempre più industriali dell’immaginario di massa che soggetti produttori di cultura. Tantomeno sono preoccupati di educare giovani generazioni alla scelta del libro di qualità letteraria. Quanto poi al compito che alcuni di quegli editori un tempo si davano, cioè di favorire la ricerca letteraria, accogliendo nuove proposte, separando la ricerca del mercato, almeno a certi livelli, questo è un atteggiamento quasi abbandonato da tutti. Eppure, c’è da dire, nonostante questo, che la poesia e la prosa, insomma il fatto letterario come invenzione di testi, di scrittura, di mondi formali, resisterà e si allargherà. Sarà certo più difficile distinguere, più difficile ritrovare nell’opaco il luminoso, nel grigio l’azzurro, ma si creeranno nuove forme di aggregazione, nuove cerchie intellettuali, nuovi sistemi di circolazione.
Mi parla del libro ideale? Quello che Antonio prete vorrebbe scrivere più di ogni altro…
Penso a un libro che sia insieme poesia, saggio, racconto. Un libro del quale non si possa dire se non che è un libro dove la lingua abita con la sua vita, il suo ritmo, e dove la forma è tutt’uno con il pensiero. Un libro impossibile, forse. Ma senza un libro impossibile all’orizzonte credo non si possa scrivere niente.
Estratto dell’intervista posta in appendice a <<Ermeneutica e “pensiero poetante” negli scritti di Antonio Prete>> | Tesi di Laurea di Carla Saracino in Critica letteraria e letterature comparate, a.a. 2005/2006, Università del Salento.






Marisa Saracino
Ottima intervista. Quando le cose si chiamano e richiamano. Mi sono andata a ripescare il nella sdimo libro di Jabes, Il Libro Delle Interrogazioni, Edizioni Elitropia. Fantastico. Grazie, Carla, mio tesoro.