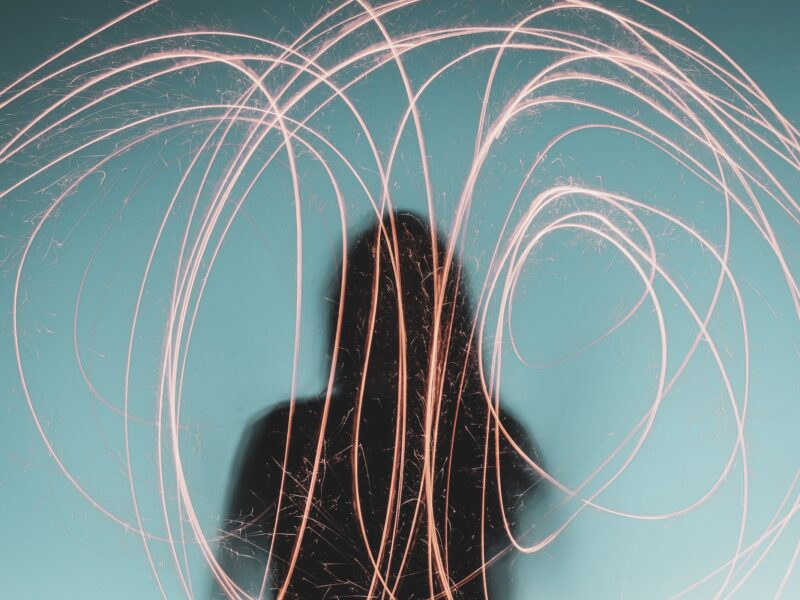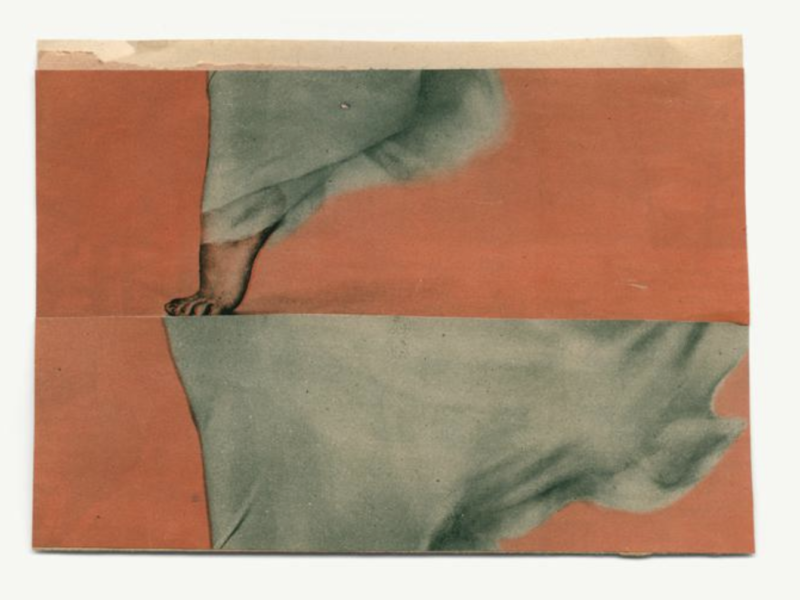Saracino | Atto e Destino
«Aggia fatte a sarte pe ttanda tiémbe / n’agge chesute de rrobbe e crestijane / tajèrre, soprabbete, giaccune de lane / e ccavezune e ggonne e ggelettiédde […]». In Scurije (Lietocolle 2005), Assunta Finiguerra scrive d’aver fatto la sarta per molto tempo. Nella schiettezza frontale di questa autopresentazione, la sua voce e la lingua appaiono pulsanti; nell’indeterminatezza del tempo, Assunta Finiguerra può consegnarci a una inquietante verità: ogni atto che ci sopravviva deve avvenire secondo un preciso esercizio. Riconoscere l’inevitabilità di questo esercizio significa avere a che fare con il proprio destino. E il destino agisce, spesso, sul lungo periodo, lasciando in una specie di otre itinerante colui che di questa sorte porta il peso: «Chi nassce già segnate da u destine / adda avé a che ffà sembe cu turmiénde / da sole adda affrunduà tembeste e viénde / e ssope o cuarre i vinde fenì abbuole […]».
Come in una sartoria che da reale diventi poetica, il cucire di Assunta Finiguerra non è più quello del rituale quotidiano chiamato mestiere, bensì l’altro, il cucire che salda i versi incidendoli sulla pagina bianca. Ma la sua poesia ha i fili tesi, non incornicia un arazzo gentile, ha i lacci nell’ago impressi come la parola dentro l’inchiostro che tenta l’eternità. Non casualmente quella dell’autrice lucana è una poesia che del corpo moltiplica e ugualmente riduce, facendosene beffe, i giochi del piacere e dell’affanno. Un corpo tirato fino allo spasimo, una biografia materica che si volta e rivolta attraverso la parola, che possiede la graffiante ansia d’essere giustamente approvata e riconosciuta, non per un capriccio della vanità, ma per una conferma dell’esistere.
Laddove il corpo prostrato stenta, perché all’inquietudine non c’è mai fine, subentrano le creature di una tradizione letteraria che giustamente Pier Mattia Tommasino, nella prefazione alla versione dialettale di Pinocchio ideata dall’autrice, Tunnichje (Lietocolle 2007), ha definito «panmeridionale». Felice osservazione, quella di Tommasino. E infatti uno spirito panmeridionale soffia sull’incantamento della poetessa zappatora (la definizione è tratta dalla tesi di laurea di Alessia Santamaria dedicata all’autrice). Questa autoqualifica, assurta quasi a nome proprio, è stata dalla poetessa giustamente indovinata: zappare, parola così inospitale persino nel suono, è arte indocile; zappare è scagliare la lama sulla spumosa consistenza della terra, provocare un danno necessario per preparare a miglior vita il terreno sotto i piedi. La poesia, corporalità intrinseca, diventa allora anche un sacrificio, un sacrificio per il bene: fuori da ogni retorica estranea al cuore, il bene della Finiguerra è l’Amore. Un Amore che si tocca, che è identificabile, che non appartiene alle privazioni degli stereotipi cui ci abituano fin dalla nascita e a cui la poetessa stessa, originaria d’un piccolo paese della Basilicata, è stata per lungo tempo sottomessa (mentre s’agitava in lei il demone della ribellione, l’angelo travestito da maschera insofferente, il desiderio che stava sotto le vesti di un mendico). L’Amore della poetessa è voluttuoso, capace di lottare con la vita, sguainarne il significato, portarlo in fronte come segno della preda conquistata. Il grande dramma della Finiguerra, ma anche la sua recondita energia, è originato dall’indisposizione del mondo ad accogliere il vortice in petto del suo dono. Da qui, forse, proviene l’elezione del dialetto. Se non è il mondo ad appropriarsi di lei, ella s’approprierà del mondo attraverso la sua antica lingua: l’unica strada proponibile, per questa guerriera il cui lamento è in realtà intolleranza al non poter godere, diventa la lingua dei padri, delle famiglie di San Fele, disperse nell’album di sbiaditi fotogrammi. Ma che strana simbiosi si crea tra la Finiguerra e il vernacolo! Una figliolanza che doveva accadere da sempre. Si piange, si ride, si ama, si grida in dialetto. Il dialetto è la sincronia della vita che si dipana incarnandosi nel vissuto. Il dialetto, per una natura indomita come quella che fu di Assunta Finiguerra, è il getto da cui si origina il rapporto sensuale e diretto tra sé e sé, sé e gli altri, sé e la letteratura.
La poesia dialettale della Finiguerra ha il timbro netto di ciò che classicamente sa di pre-culturale o post-culturale per assurdo, per un giro folle attorno alla cinghia dei titoli cattedratici. «Tenghe a càttedre a scóle d’u turmiénde/ re mmalepatènze mbare de l’amore/ poche studiénde hanne a chiòcca bbone/ e cchi re fface pecché le vatte u córe […]» [Ho la cattedra alla scuola del tormento/ le sofferenze insegno dell’amore/ pochi studenti hanno voglia d’imparare/ e chi lo fa perché gli batte il cuore]. L’allusione parodica agli accademici c’è ma è tanto lieve e forse neanche così voluta. Ben più prioritario è trasmettere al lettore d’essere maestra di stati interiori convulsi e mai sazi, figli della cupidigia delle cose belle, delle cose tutte, equivalenti a un vivere autentico e scevro da mediazioni vischiose o pre-occupate. C’è in Assunta Finiguerra il respiro verticale delle voci classiche, di quella lirica che agisce nel mondo per cantarlo e insieme scuoiarlo mano a mano, fino a vederne l’essenza, il nocciolo stregato dal mistero che lo sottende. Anche per questo, la poesia della poetessa-zappatora trabocca come di un empito di suggestioni che della terra d’origine mantengono il nucleo cromatico ancestrale. Volendo infatti riprendere più da vicino il senso delle parole del Tommasino, il panmeridionalismo dell’autrice è ancora una volta corpo in congestione, corpo in diretta. L’affastellarsi di figure mitiche, le imprecazioni, le comparazioni fra gli oggetti e l’umano o l’umano e la legenda archetipica dei sentimenti, sono colori sgargianti sulla tavolozza di una poetessa che non rinuncia ad entrare nella classicità del sentire mostrandosi al pari d’un oracolo, una bocca della verità sguaiata, talvolta, nel senso della crudezza del dire. Chi è classico non può rinunciare alla crudeltà, intesa come atto di coraggio verso la nominazione del male. Cancro, coltello, unghia, tagliola, mastino, squartare, strappare: questi, tra verbi e nomi, sono solo alcuni dei gradienti linguistici della mordacità verbale della Finiguerra.
Del resto, scrivere poesie è spogliarsi d’ogni pudicizia che nel linguaggio freni il conato delle nostre rinunce. Essere crudi significa essere se stessi e poter vivificarsi nello stile. Essere crudi, talvolta, significa auspicare un ordine in grado di mettere a tacere per sempre il caos delle condanne e ripristinare un’integrità e una forma di benessere. Questo benessere è cercato ed esplicitamente reclamato dalla Finiguerra. Ce lo suggeriscono i giochi estremi di alcune chiuse in Scurije: «Oje vita vita vite guàrdeme nfacce / nun só nu bboje c’accide a ggende / vulesse avé nu poche de firma mende / e nu becchiere mane de verdéche […]» [O vita vita vita guardami in faccia / non sono un boia che uccide la gente / vorrei avere un po’ di firmamento / e un bicchiere in mano di verdeca].
Non è infrequente, nei versi dell’autrice, l’entrare in un mondo fatto di equivalenze tra il soggetto lirico, i sopralluoghi di ciò che è esistente e l’esistente fine a se stesso, quello della materia prima, degli oggetti che stanno, assorti, nella quotidianità: oggetti semplici, pezzi di vissuto giornaliero (a voler rimarcare l’assoluta identità tra la vita e la poesia).Eppure, nella sua produzione si scontrano tempeste del sentimento e sorsi spiccioli di blanda distrazione quotidiana; evidenza che ha la forma della familiarità domestica e reazione metaforica a questa stessa idea di normalità. Una serie di laceranti contraddizioni che determinano le accensioni aggettivali dei testi, gli svettanti lamenti che gridano sulla pagina e che si trasformano in propositi di controrivoluzione, battesimo del tempo convocato e stracciato, invocato e maledetto.
Il lamento della Finiguerra è un canto guerriero e non può conoscere lo spreco. Lo spreco è il feticcio negativo dell’autrice, il maligno da abbattere; la dispersione è la passione da recidere. Assunta Finiguerra mira alla composizione di uno stato della sazietà. Una fame incontrollata la possiede e perciò, di fronte ad essa, deve sfoderare ogni strategia d’attacco e ogni piano di difesa. Il suo nemico è la fame, la fame della vita. Leggiamo ancora da Scurije, «e m’afferraje a re trézze d’e l’amore / quanne avvertije nu picca terramote / quanne me ngaddije a vvócca aperte / u zenzelicchje d’u delore o maestrale» [e mi afferravo alle trecce dell’amore/ quando avvertivo un grande terremoto/quando tonificavo a bocca aperta/ l’ugola del dolore al maestrale].
Nelle ultime pagine di Scurije (Lietocolle 2005), ma anche nelle ultime produzioni poetiche apparse nell’Antologia del premio MezzagoArte, Questo dolore che mangia (Le Voci della Luna Poesia, 2009), quell’assoluto bisogno di dare concretezza al mancante diventa insostenibile, una croce che ha veramente il significato della sacralità, la sacralità di una responsabilità verso se stessi e la bellezza in assoluto. La voce guerriera è esausta e non è più sufficiente ad aprire l’estasi della liberazione. «Nun m’abbaste cchiù scrive poesije» [Non mi basta più scrivere poesie]. Ormai la parola ha finito, nei suoi sarcastici e irruenti slanci di offerta, di agire. Bisogna quasi disimparare l’amore, bisogna quasi accettare quella dissipazione «cume l’inghiostre ca ténge re mmane» [come l’inchiostro che tinge le mani] che vede nello sperpero l’unica fuga dall’ossessione del potere taumaturgico del cuore. La morte fa una comparsa più esplicita nelle battute ultime della poetessa, è una figlia che viene a nascere e a prendere le redini di un’eredità: sarà l’eredità privata del rimpianto? Del non essere riusciti a diventare ciò che si sarebbe voluto? No. La morte sarà un destino comune e toccherà tutti, prenderà le sembianze delle colpe e i rimorsi d’ognuno, infine chiuderà il coperchio del chiasso e restituirà pace a tutte le vite precocemente spezzate.
Featured Painting by Valentin de Boulogne | The Fortune Teller with Soldiers (c. 1618-20). Toledo Museum of Art. 149,5 x 238.5 cm