Saracino | Il rischio dello sguardo
Scriveva Marina Cvetaeva ne “Il poeta e il tempo” che la volontà creativa è la pazienza. E la pazienza è una terra apparentemente immobile dove le cose si manifestano per restare integre appena un poco prima della loro assegnazione definitiva.
Così, nella terra della pazienza, l’atto più semplice e umano che possa compiersi è il guardare.
Ciò che forgia l’anteriorità di un pensiero fondato sull’esistenza è lo sguardo; ciò che ha impresso nell’umanità il bisogno di affermarsi ed inscriversi come un’insegna sulla esperienza della vita e della morte è l’incisione nello spazio del proprio divenire. Non il guardare sperduto di chi si avvia alla vita attraverso il lume di un sé mai riconosciuto né quel vedere rassegnato e permissivo di chi acconsente a farsi condurre dagli altri, bensì l’osservazione quasi “vana” – il passare verso ciò che frontalmente invoca la nostra interpretazione senza per questo tentare di estirparcela con la forza o i rigori di una certa retorica.
La propria terra di battesimo è la nascita, dove sorge un paese che porta il nostro stesso nome, ai cui confini interagiscono, in una sequenza che ha del meraviglioso, tutti i tempi delle nostre potenzialità. Le potenzialità stanno sulle strade, assorte ma anche invitanti come delle scarlatte forme del desiderio venute fuori da un prisma rimasto per lungo tempo al sole della verità.
L’occhio, allora, non solo come occasione inquieta di percezioni che accendono il senso della curiosità del vivere e quindi il dovere di accostarsi a ciò che intorno a noi esulta nella formidabile espressione della rivelazione, ma pure come esperimento del rischio del dolore nel quale entrare senza esitazione compiendo il gesto della responsabilità e della intimità con esso. L’occhio come sublimazione di una domanda, esercizio verso la chiarezza dell’essere promessi all’esistenza attraverso l’agilità di un proporsi senza ossessioni né scrupoli, senza false pose o anticipazioni retoriche, ma con pieno spirito di perseveranza e accettazione.
Occorre devozione per sentire che la vita ci è in mano e scorre come un elemento che irriga la pianta del nostro ibrido corpo. La devozione è un atto di estrema libertà, più che di umiltà, perché non si oppone al nuovo, anzi lo esorta a farsi avanti, a formarsi come un impegno suggellato secondo antiche pratiche, a costruirsi con una logica imparziale e per questo giusta. Nella devozione noi siamo al centro delle debolezze e delle forze che il mondo intavola e siamo in grado di scinderle, elevandole non a categorie ma a possibilità di trasformazione in un valore estetico (ed etico).
Ma il nuovo cos’è? È tutto quello che, pur non restando immune da futuri codici classificatori, prima di tutto ci chiama nudo e silenziosamente ci offre il suo archetipo. Ogni cosa “nuova” ha il suo archetipo sedimentatosi dai millenni: i millenni lo hanno accompagnato nel suo essere “mitico” fino allo spasimo e lo hanno caricato di suggestioni pre-culturali tali per cui, quando riusciamo a riconoscerlo, esso diventa per noi familiare al punto da darci la sensazione di averlo appreso da sempre.
“Quanto volli dire che i miei versi non dicono, quanto i miei versi dicono che non volli dire”, scriveva il poeta spagnolo Gimferrer, a riprova del fatto che il salto tra l’aver detto e il non aver detto è esattamente ciò che nello sguardo individuale si è definitivamente custodito o definitivamente perso.
Saper guardare è soprattutto atto di coraggio, è accoglienza disillusa anche delle brutture del nostro riflesso di cui, in uno stagno addormentato, potremmo accorgerci, almeno una volta nella vita. Saper guardare è lenire le perplessità, potenziandole; è curare le agitazioni, soffrendole; è commuovere la nostra stessa solitudine.
Presentificare lo sguardo è operazione quasi magica, se veramente osata, senza indugi o peggio mistificazioni, da chi vuole entrare in quella dimensione del tempo così bistrattata: la profondità.
E sebbene il tempo notoriamente rovini, l’osservatore ha tra le mani la possibilità per un attimo (infinito in se stesso) di sospenderlo e preservarlo dalla frattura con ciò che è mortale. In questo attimo (nel quale ogni cosa ritorna a se stessa) presentificare è il miracolo fatto dall’uomo, la “fiamma della candela” del sognatore di Bachelard la quale quanto più brucia meglio ascende poiché insiste nella conquista del paese della luce.

In questa visione accesa, in questo discorso del far decantare e del far permanere, si inscrive l’esperienza della fotografa americana Lynn Davis, che nei suoi lavori “pubblica” il perpetuo incarnarsi dello sguardo attraverso il coraggio della contemplazione. Granitici, scultorei e magnanimi, i suoi soggetti sono le grandi costruzioni della natura impervia o quelle realizzate dall’uomo, cavalcanti i secoli, le civiltà, le onde della storia.
Il suo occhio appartiene alla più estrema delle operazioni: spingere in avanti, col coraggio della resistenza, il destino di ciò che è grandioso, fermarlo nella necessità del fotogramma, insistere sulla possibilità – anche – della sua effimera vita. È in lei la solenne aspirazione di chi, non accontentandosi, chiama a sé il meraviglioso assumendolo a connotato, metafora, sublimazione di un certo modo di vedere e far volgere la vita. “Educare” l’occhio a ciò che è grandioso e scolpito da manifatture eccezionali diventa allora, forse, la migliore cura in questo mondo così decelerato nella stagnazione di scetticismi, paure e diffidenze. Come possiamo trarre coraggio e conforto in questi tempi vulgati da noi stessi, targati dal rischio della decadenza spirituale, sociale e nondimeno dalla minaccia pandemica che avvolge il nostro corpo dentro una veste di corazze e incerti artifici? Come possiamo? Accendendo il rischio dello sguardo su quanto è extraordinario, sembrerebbe voler suggerire Lynn Davis, la quale non a caso fotografa le sue immagini in un grande formato e in bianco e nero. Alle estremità del colore, il bianco e il nero possono documentare la dimensione della profondità, che è sempre anzitempo, posteriore al tempo e fuori da ogni tempo, dunque eterna, insuperabile, “indimenticabile”.
Che il contesto della pandemia e le parole dei media ci abbiano sotterrato in una mole di informazioni, è fuor di dubbio. Che questo fatto tradisca il naturale bisogno dell’uomo di sentirsi parte, insieme ai suoi simili, di una comunità in perenne dialogo, pure è assolutamente realistico.
Tuttavia, non dovremmo dimenticare che dalla solitudine e dal silenzio nascono le forme del nostro attrito con la vita. E che da ogni attrito o sfregamento, emerge il “nuovo”.
La natura, in questo senso, ce lo insegna, modellando e rimodellando senza sosta la sua fisionomia, il suo rapporto con le cose, gli eventi, i fenomeni. È allora che la grandezza dell’opera “Iceberg #23, Disko Bay, Greenland, 2000” di Lynn Davis può assemblare l’occhio nella trama dell’eccezionale. Mentre noi uomini, spersi per le città satellitari del contemporaneo, ci affanniamo, chiacchieriamo, ci insultiamo o amiamo ininterrottamente e talvolta senza coerenza, da qualche altra parte della Terra la natura svetta nel suo iper-realismo e nella sua iper-lirica siglando il vero rinnovamento. Quei due grandi e vegliardi blocchi di ghiaccio di diverse misure stanno lì a rivelarci il potenziale sguardo “ulteriore” e a dirci che un mondo deputato al “saper vedere” oltre i limiti del proprio approvvigionamento non solo è possibile ma anche clandestinamente vicino a noi.
Featured Image: Iceberg #23, Disko Bay, Greenland, 2000 by Lynn Davis


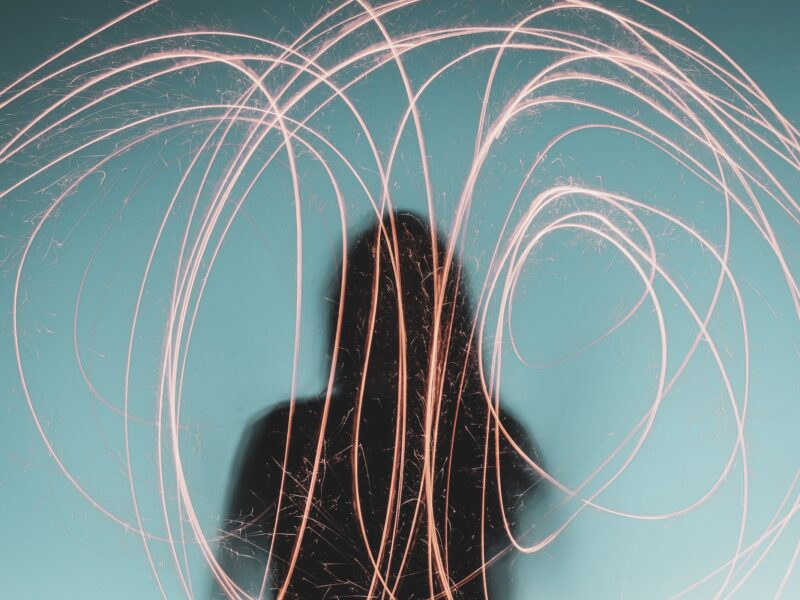
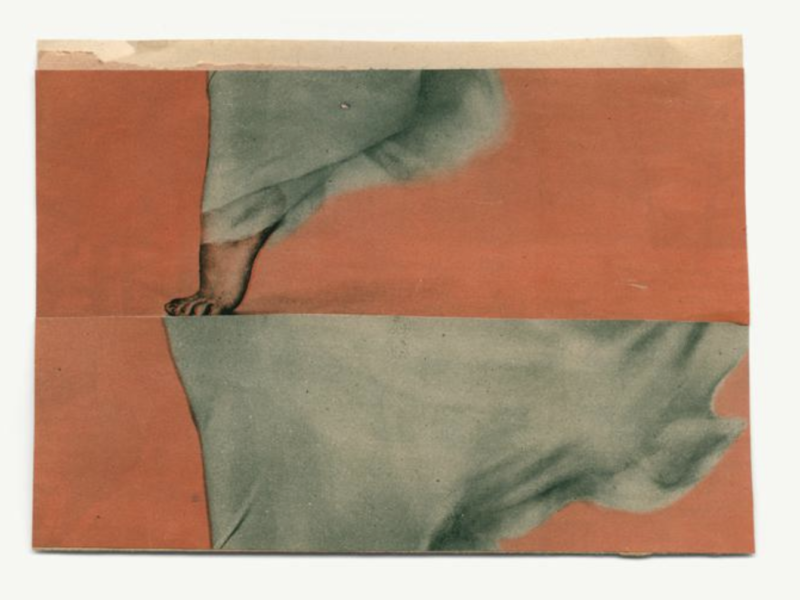


Ilaria
Grazie, Carla