Zoppelli | Fiction, Realtà, Utopia
In una sua lirica, Niccolò (in Stella variabile)1, Vittorio Sereni parla del “tu falsovero dei poeti”: che cosa o chi intende? Forse un interlocutore – in presentia o in absentia – o qualcuno a cui essi nei loro versi si rivolgono, ma che forse – in quanto tale – nemmeno esiste nella realtà o non esiste così come appare nel testo (altrimenti sarebbe, nella lingua di Sereni, un “tu vero”); o forse, ipotesi più plausibile, quel tu sei tu, caro poeta. Cioè egli oggettivizza ed esternalizza sé stesso al di fuori di sé, inventando – come interlocutore – qualcuno che è solo la proiezione dell’io poetico, un escamotage per parlare ancora e sempre di sé con sé stessi, una sorta di camuffato monologo interiore sotto le mentite spoglie, se non di un dialogo, di un fantomatico testimone e di una fantasmatica presenza altra a cui rivolgersi. Se a ciò aggiungiamo che l’io poetico è cosa diversa dall’io biografico la questione si complica ulteriormente. E c’è sempre la possibilità che quel tu si riferisca – anche indirettamente anche involontariamente – al lettore, chiamato in causa, trascinato dentro il testo, così da operare una sorta di coinvolgimento emotivo, di immedesimazione, di autoriconoscimento e di complicità, una sorta di appello all’hypocrite lecteur di baudelairiana memoria.
Insomma, a quale livello si colloca la verità? Evidentemente non a quello dell’io empirico, poiché lo stesso io poetico è spesso una costruzione letteraria che non si sovrappone perfettamente all’io esperienziale e non coincide con esso; non a quello del “tu falsovero”, poiché spesso è un pronome fittizio proiezione, alienazione e reificazione dell’io poetico; non a quello, tanto meno, dello sconosciuto e “ipocrita” lettore; non resta che la verità dell’io poetico che, però, si pone su un piano diverso da quella fenomenica e dalla verità come “constatazione di fatto”, tanto più che, come detto, egli è una costruzione e una strategia tutta letteraria, anche quando vuole essere “autentico” e “onesto” (lo sono in massima parte anche quelli di un’autobiografia o di un diario). L’io poetico può benissimo essere “falso”, frutto di invenzione e fantasia (pur radicato profondamente nell’io che vive), o rifrazione di un’immagine di sé distorta, addirittura nutrito di tutti gli io incontrati, eppure in grado di esprimere le più profonde e condivise verità umane, purché non vadano cercate in quelle di un io reale che le abbia per forza vissute nel modo in cui sono dette nel testo poetico, semmai di un io che si fa universale; o non siano scambiate per verità in senso scientifico, tanto più che – a volte – i fatti a cui si riferiscono non sono mai nemmeno accaduti, e dunque anch’esse possono essere – sul piano del reale – “false” in quanto non fattuali e in quanto si muovono nell’ambito della finzione (evidentemente il viaggio di Dante nei tre regni dell’oltretomba è vero solo nella finzione e non è mai avvenuto nella realtà, così come i suoi tanti incontri).
Benché i filologi, i linguisti, gli storici, i critici si affannino giustamente ad illuminare ogni più recondito angolo del testo e dell’opera letteraria, in fondo al lettore poco importa se davvero quel fatto o quell’altro, quel personaggio o quell’altro rappresentati nel testo poetico siano davvero avvenuti o esistano davvero, purché quella poesia esprima una condivisibile e condivisa verità umana, quella sì vera, anche se passata al fuoco del “falso” o – direbbe Manganelli – della “menzogna”. È poi così fondamentale, mettiamo, sapere se Beatrice, Laura o Silvia sono realmente esistite e, se lo sono, se sono proprio quelle di cui parla il poeta, o non piuttosto da lui idealizzate e stilizzate? È poi così fondamentale sapere che Silvia potrebbe essere Teresa Fattorini, la figlia del cocchiere di casa Leopardi? Su questa esistenza si basa la verità del testo o, non piuttosto, sul suo significato simbolico e universale? Non conta forse – ad esempio – che Silvia sia il simbolo della giovinezza tradita e di tutte le giovinezze tradite di ieri, di oggi e di domani? Paradossalmente, a volte, in un testo poetico le ragioni della rima surclassano addirittura quelle della realtà effettuale: sono convinto, ad esempio, che Giovanni Raboni decise che – in un suo verso – l’infermiera fosse “vietnamita” solo perché faceva rima con “vita” (magari è esistita questa infermiera, ma era – che ne so – rumena o peruviana o filippina). Il poeta ha fatto sì che la realtà venisse adattata all’imperio della rima, più cogente per l’artifex della realtà stessa: «Ah no, non a un filo soltanto / era attaccata la mia vita / ma al buffo intrico ch’era vanto / dell’infermiera vietnamita» (in Ogni terso pensiero)2. Il “falso”, nell’arte, a volte è più vero del vero, o di quello che riteniamo tale.
La verità che risiede nell’opera d’arte, intesa dall’ermeneutica come apertura di senso, orizzonte o forma conoscitiva oggetto di interpretazioni infinite, si contrappone alla verità come “constatazione di fatto” tipica delle scienze. Oltretutto il linguaggio letterario è polisemico, mentre quello scientifico è monosemico, e l’immagine, la metafora, il simbolo che veicolano la verità artistica sono inesauribili, non circoscrivibili in una definizione esaustiva o in una formula scientifica. Il che comporta una concezione della realtà più ampia, ricca e articolata di quella puramente fattuale, percettologica, materialistica o scientista, che non riesce ad essere fedele alla complessità del mondo proprio per il suo tratto riduttivo. La realtà, infatti, è un campo di tensioni, entro il quale si situa anche l’apertura utopica operata dalla poesia: “utopia” da intendersi nel senso di una «costante apertura verso il perseguimento non mistificato di possibilità diverse da quelle già sperimentate»3. Ernst Bloch ci ha insegnato che l’utopia e la speranza non riguardano solo passate età dell’oro o il futuro, ma il presente, e non riguardano solo luoghi esotici o isole felici, ma l’hic et nunc: da qui la loro insuperabile attualità4.
Il principio speranza e l’utopia blochiana rendono più piena e completa la lettura e la comprensione del reale, il quale non coincide semplicemente con l’amministrazione del presente, con la superficie della realtà, con la sua presunta immobilità, con il realismo volgare irrigidito in un eterno presente: il reale è dinamico, è movimento, è un campo di tensioni, di contraddizioni, di latenze e di possibilità, in cui – ad esempio – si fanno “sogni ad occhi aperti” e in cui il desiderio rappresenta il mondo non così com’è, ma come dovrebbe essere. In questo senso si potrebbe persino dire che la poesia stessa è un sogno (individuale) fatto in pubblico; ecco: le poesie sono “sogni sociali”. Tutto ciò comporta un’attenzione privilegiata non tanto per il futuro quanto per il presente col suo “sovrappiù anticipante” e il suo contenuto latente, e un’assunzione di responsabilità nei confronti della progettualità umana dentro un presente che è una stratificazione di più tempi, una compresenza di ritmi temporali, una poliritmia, un multiversum, una compresenza di diversi strati temporali. Ovvero il preapparire utopico, l’anticipazione soggettiva e il non-ancora-divenuto nel mondo: per questo la poesia sembra rientrare nella categoria blochiana dei sogni ad occhi aperti.
Dell’utopia, indubbiamente, si possono dare le più diverse e contrastanti definizioni, ma quella più produttiva per noi oggi e che più si avvicina all’idea dell’utopia della poesia5 è di Ernst Cassirer – ricordato da Mario Trombino – secondo il quale il pensiero utopico ha lo scopo di «Creare spazio al possibile: contro ogni passiva acquiescenza allo stato presente»6; cioè l’utopia non ha il fine di costruire un mondo perfetto, così come sarebbe bene non credere in un mondo una volta per tutte e definitivamente riconciliato con sé stesso o nella possibilità di raddrizzare una volta per tutte e definitivamente quel “ramo storto” che – kantianamente – è l’uomo, al prezzo di spezzarlo. La storia ha condannato inappellabilmente, questa volta sì un volta per tutte, tali esperimenti. Non dunque lì vanno cercate “speranza” e “utopia”, non nei progetti di un mondo perfetto o nella creazione di un uomo nuovo; piuttosto nella coscienza che “speranza” e “utopia” rappresentano una «apertura costante, continua al diverso: l’utopia come lo spazio aperto ad ogni possibile, e perfino all’impossibile come luogo ideale di valore»7. Insomma, un’utopia – potrà sembrare paradossale e un controsenso – del qui e ora, e non dell’altrove o del futuro più o meno prossimo.
La poesia compie un’apertura di senso altro, che a sua volta apre ad altri mondi e universi, più o meno paralleli, fossero anche solo mondi sonori (privi, in apparenza, di senso e di significato; ma sappiamo che neppure la musica lo è), con la sua peculiare forma e le sue risorse retorico- linguistiche, col suo effetto straniamento, col suo diverso ordine logico-sintattico del discorso, con i suoi scarti e le sue infrazioni alla norma. La poesia, sul piano linguistico e rispetto alla lingua d’uso, presenta un “altro ordine del discorso” (anche solo sintattico: inversione, anastrofe, ipèrbato, anafora, anadiplosi, chiasmo, parallelismo, climax, ellissi, polisindeto, asindeto ecc.). Già solo per questo la poesia è una lingua altra, straniera, già solo questo ne sottolinea l’alterità rispetto alla lingua d’uso. Ma la poesia si richiama anche a un universo simbolico diversamente ordinato rispetto a quello diurno, più vicino a quello diuturno del sogno e dei sogni ad occhi aperti; anzi, essa riordina simbolicamente il mondo secondo altri criteri, che non sono quelli della sola ragione, a partire ad esempio dal desiderio, o secondo priorità etiche. Riordina simbolicamente il mondo non sempre secondo il “principio di realtà” ma seguendo – e inseguendo – il “principio di piacere”. Al poeta non interessano solo le cose così come sono ma, suggerisce Wallace Stevens in The man with the blue guitar, come dovrebbero o potrebbero essere. Per questo egli ha una visione più completa e non superficiale del reale: non si limita alla conoscenza e alla comprensione della realtà, ma la trascende, e questa forma di trascendenza è già da sempre l’utopia.

La poesia riordina simbolicamente il mondo secondo le priorità del desiderio e del “principio di piacere”, secondo una logica binaria in cui non sempre vigono il principio di identità, il principio di non contraddizione o il “principio di realtà”; riordina simbolicamente il mondo – in quanto “realtà di finzione” (secondo la filosofia del dialeteismo di Graham Priest) – semmai secondo il “principio speranza”, il libero gioco della fantasia e delle illusioni, e le leggi dell’immaginazione creativa. Scrive Herbert Marcuse: «L’arte rappresenta una sfida al principio della realtà corrente: rappresentando l’ordine della sensualità, essa invoca una logica repressa – la logica della soddisfazione contro quella della repressione. Dietro alla forma estetica sublimata si annuncia il contenuto non sublimato: la dipendenza dell’arte dal principio del piacere»8. Più che insistere sui caratteri di continuità, di contiguità, di interdipendenza, di commistione – che pure esistono – tra la lingua della comunicazione e la lingua della poesia, tra la prosa e la poesia, tra il prosaico e l’aulico, vale forse la pena sottolineare l’alterità del discorso poetico e del suo linguaggio, i caratteri di discontinuità e di differenza, a partire dalla formalizzazione in versi (misura, metro, distribuzione degli accenti, ritmo, musicalità ecc.) e dalla specificità e densità linguistica, passando per la sua capacità di rivitalizzare la lingua, per arrivare infine all’immaginario e all’apertura e all’istituzione di mondi altri, di mondi possibili, di universi paralleli, e all’apertura di senso e di intramondi intravisti.
Resta che la stessa ontologia poetica è altra rispetto a quella della scienza o a quella della filosofia, sia sul piano conoscitivo sia sul piano della lingua: «la poesia possiede il suo oggetto senza conoscerlo, la scienza (o la filosofia) lo conosce senza possederlo»; e ancora oggi «noi consideriamo comunque altro rispetto al discorso comune quello poetico, perché in grado di attualizzare potenzialità del linguaggio normalmente non impiegate o non prese in considerazione»9. Oggi ricorriamo alle teorie delle scienze cognitive per provare a spiegare la specificità, l’alterità e l’a-razionalità dell’ispirazione poetica, considerando i testi letterari in una dimensione dinamica tra cultura e biologia, e individuando le «conseguenze percepibili nei testi poetici di un processo di pensiero e metaforico che evita in prima istanza la connettività di tipo logico-sintattico, o che la usa ma senza curarsi dei vincoli della non-contradditorietà e della consequenzialità, pur rimanendo in qualche modo dotata di senso»10. Non si tratta di riconoscere solamente, a livello fonetico-ritmico, l’esistenza di una base “universale” della ritmicità poetica presente sin nelle lingue più antiche (il battito del cuore materno tra l’altro – se vogliamo radicare ancora di più nel fisiologico il discorso poetico – informa e cadenza il ritmo di vita del feto), rimandando pertanto ad una percezione fisiologica del poetico, ma di individuare «gli aspetti pre- logici e pre-sintattici che possono essere accettati nel discorso poetico e addirittura organizzarlo in profondità»11. Se il linguaggio, indipendentemente dalla sua origine alquanto discussa, si sviluppa in modo intrinsecamente metaforico e analogico, allora il linguaggio poetico non costituisce «una specializzazione di quello comunicativo, bensì una sua forma alternativa, la quale per lungo tempo è stata impiegata soprattutto con un valore sacrale, implementando gli aspetti del significante (soprattutto dei ritorni fonici) e del ritmo piuttosto che quelli della costruzione sintattica complessa»12.
È bene anche sottolineare la valenza conoscitiva del “poetico”, in particolare le «potenzialità ricavabili dal linguaggio poetico in quanto creazione attraverso la metafora». L’organizzazione ritmico-simmetrica è uno dei possibili sviluppi dell’attività cerebro-mentale nell’ambito linguistico; per di più «la capacità di collegare parole e pensieri per via analogico-musicale resterebbe in potenza anche dopo lo sviluppo dell’attività razionale, e potrebbe favorire la creazione delle metafore complesse e dei linguaggi “altri” (espressionisti, nel senso più generico del termine) rispetto a quelli standard, grammaticalizzati-comunicativi»13. In quarta di copertina del libro di Alberto Casadei, Poesia e ispirazione (2009), è data una definizione della poesia che bene si concilia con la sua dimensione utopica, anzi il suo tentativo di reperire i fondamenti “biologici” della poesia, finisce – in qualche modo – per individuare anche quelli dell’utopia della poesia: «La poesia diventa una modificazione della prospettiva cognitiva: uno scarto del pensiero, necessario e urgente in quanto capace di rendere concepibile un’alternativa al reale». La poesia è di per sé, nelle sue connessioni tra linguaggio e attività psichica, nei suoi processi mentali, nel suo rapporto “biologico” con la mente-cervello, nelle sue procedure analogiche, nelle sue creazioni metaforiche, nelle sue infrazioni sintattiche, nei suoi fondamenti fonetico-ritmici inscritti nel fisiologico ecc. ecc., la poesia – dicevo – è di per sé utopica, in quanto – appunto – rende in tal modo concepibile un’alternativa al reale.
In quanto promesse de bonheur, l’arte vera dovrebbe sempre servire il futuro, l’alterità, istituire mondi altri e universi paralleli, deviare anche solo il nostro immaginario, dilatare anche solo il nostro orizzonte di esistenza, in quanto ri-creazione e reagente chimico a contatto con il mondo della vita: «intendo professare – scrive Seamus Heaney – la sorpresa della poesia quanto la sua affidabilità; voglio celebrare la sua fisicità costante, imprevedibile, il modo che entra nel nostro campo visivo e anima il nostro essere fisico e intellettuale, un po’ come le sagome di uccelli incollate su vetri e finestre devono entrare improvvisamente nella visione e cambiare la direzione del volo degli uccelli veri. In un lampo queste sagome sono percepite e trasmettono la loro presenza inconfondibile, e gli uccelli deviano istintivamente. Un’immagine delle creature vive ha indotto un cambiamento di direzione del tutto salutare nelle creature stesse»14. Ecco, la “finzione” poetica, come le sagome di uccelli incollate sui vetri delle finestre, può far cambiare e deviare la direzione del nostro sguardo sulle cose del mondo. La poesia, tra essere e dover essere, esprime comunque un carattere alternativo, una irrinunciabile tensione utopica, che è anche forza etica contrastiva: sempre il poeta-stranger here formula una verità-finzione in una lingua-autre di una realtà-ou-tópos.
Questa è la verità della poesia, fiction o fedele alla realtà che sia, e non è tenuta al rispetto dei fatti, del reale, della storia, della scienza, dell’ideologia ecc. perché rimane un prodotto della creatività, dell’immaginazione, della finzione, del libero gioco della fantasia, del desiderio e dell’illusione, ponendosi il suo carattere veritativo su tutt’altro piano, di certo non su quello della verità fattuale, anche quando decide di rappresentare la realtà e la Storia, quanto su quello – altrettanto reale – delle semplici, “eterne” e universali verità umane (che spesso sono quelle delle emozioni, della gioia e del dolore, dei grandi interrogativi dell’umanità sulla vita e sulla morte, sul bene e sul male, della vasta gamma dei sentimenti, sia positivi sia negativi, del complesso e contradditorio mondo interiore, della soggettività, del desiderio, delle molteplici passioni – anche quella civile e politica, come mostrano Dante e Farinata nella loro schermaglia dialettica, può essere una passione – dei sogni, della sfera affettiva e della libido, della tensione verso la bellezza e il vero), per questo non suona mai “falsa”, anche in mezzo al più totale artificio: «Non voglio i narcisi veri – io non amo / i gigli né le rose vere. / Ornano banali, comunissimi giardini. La loro natura / mi amareggia, mi stanca, mi dà pena – / m’annoia la loro corruttibile bellezza. // Datemi fiori finti – la gloria del metallo / e della porcellana – / forma che non declina, che non sfiorisce / e non si decompone. / Fiori di straordinari giardini situati in altro luogo, / ove Teoria, Ritmo e Sapere hanno dimora. / Amo i fiori modellati col vetro e l’oro / che dell’Arte fedele son fedeli doni; / con tinte più belle di quelle naturali, / lavorati con smalto e madreperla, / con rami e petali ideali» (Costantino Kavafis, Fiori finti)15.
2. Tutto, incontestabilmente, vero; tutto, assolutamente, condivisibile, e valido – verrebbe da dire – per ogni poeta: «Tanto Williams che Wallace Stevens, come pure Ezra Pound e T. S. Eliot e quasi tutti i poeti significativi di quel periodo, non si stancano mai di esplorare le risorse e i limiti, e anche le contraddizioni della lingua, in quanto materia prima della poesia»16. Ma un’insistenza troppo accentuata sulla lingua – da parte della filologia, della linguistica e della stilistica – e sulla sua difesa, pur necessaria, finisce – inevitabilmente – per feticizzare la lingua stessa e per sottovalutare altre proprietà della poesia. La materia prima del poeta, non v’è dubbio, è la parola, è il verbo (per lui, verrebbe da dire, “In principio era il verbo”), è la materia linguistica, come per il pittore è il colore o per il musicista il suono, e la poesia è senz’altro un prodotto verbale (si esula qui dalla poesia concreta e da quella visiva); e, in quanto materia (anche se la parola è “alata” ed evocativa), può essere diversamente impastata, non per riprodurre la realtà ma per produrre nuova realtà (anche, ma non solo, linguistica). Questa, però, è solo una parte della verità della poesia (e neanche la più interessante), la sua dimensione e fattualità linguistica. Intanto sappiamo che il poeta può assumersi la responsabilità nei confronti della propria lingua (poetica e non), in relazione con la lingua della tribù e in relazione con l’altro (oltreché con la lingua poetica della tradizione). Ma neanche questo è tutto, e la poesia non è solo materia linguistica, così come la dimensione etica non concerne soltanto la lingua: la poesia possiede un carattere veritativo e una dimensione etica più ampia. La posta in gioco – allora – è proprio il carattere veritativo dell’esperienza estetica. Con l’arte e la letteratura noi compiamo un’esperienza di verità. La poesia e l’arte dicono qualcosa di essenziale, come volevano – pur da prospettive diverse e opposte – Heidegger e Adorno, su di noi e sul mondo, dicono la verità sulla condizione esistenziale dell’uomo e sulla natura – sempre storica – umana. Altrimenti perché leggere poesie, per solleticare semplicemente l’Homo ludens? È vero: l’arte è ricreazione, divertissement, diletto, gioco, piacere, godimento, ma lo è anche nel senso più nobile ed elevato di ri-creazione, qualora riesca ad essere reagente chimico a contatto con il mondo della vita, qualora riesca anche solo a deviare il nostro immaginario, qualora ci faccia una promesse de bonheur o ci spalanchi altri mondi: «Tutte le arti contribuiscono alla più grande di tutte le arti: l’arte di vivere»17.
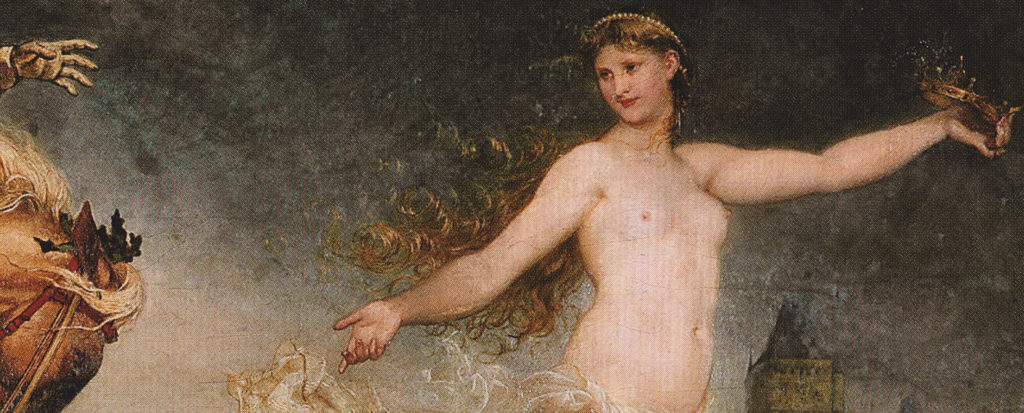
La poesia non è un sistema di segni autoreferenziali e la verità dell’arte non sta in formule quali l’art pour l’art o il verso è tutto, non sta nemmeno nel culto del testo o della testualità: «A me non interessa il bel suono, mi interessa la verità» afferma Celan18, il quale rifiuta la bellezza come valore autonomo della poesia disgiunto dalla verità. Michael Hamburger ha coraggiosamente intitolato un suo saggio, in un’epoca ossessionata dalle teorie critiche e refrattaria a termini quali “verità” e “etica”, La verità della poesia (1969, seconda edizione 1982): «Che la poesia esprima o metta in atto una verità i poeti non l’hanno mai negato, neanche quelli che sono andati ben più in là di Baudelaire nella ricerca di una sintassi svincolata dall’uso prosastico, di metafore senza alcuna funzione di sostegno al discorso, e di una scelta di parole determinata più dai valori acustici che da quelli semantici»19. Anzi, a sua volta citando Elizabeth Sewell, egli afferma che «la funzione della poesia, come quella della religione, del mito e della scienza è scoprire “la verità, nel senso più semplice e corrente della parola”»20. Se gli scrittori hanno sempre riconosciuto che la poesia esprime una verità, buona parte della responsabilità dell’eclissarsi del carattere veritativo dell’esperienza estetica ricade sulla teoria letteraria, sulla critica degli ultimi decenni e sui suoi metodi convertiti in rigidi canoni.
Se la poesia è il luogo delle verità umane, se non è serva di nessuno ma serve solo la verità – in quanto esperienza di verità – e se tale verità non può che essere “umana” o, per dirla con Simone Weil, gli scrittori «non han da essere professori di morale, ma devono esprimere la condizione umana»21; ecco che allora essa «ci mostra la verità della nostra condizione – anche se solo momentaneamente, per un attimo rapidamente eclissato dall’«oblio» e dalla «gaiezza» della routine quotidiana»22. Tale continuum della routine quotidiana è spezzato dall’improvviso bagliore di un’esplosione emotiva. Proust paragona i romanzi all’esperienza del lutto o ad altre profonde emozioni della vita che aboliscono l’abitudine e rimettono in contatto con la realtà della vita: «Le abitudini ci nascondono la nostra reale condizione – il nostro «essere bisognosi», il nostro amore per oggetti incontrollabili, la nostra vulnerabilità»23. La verità della condizione umana, il nostro “essere bisognosi”, la nostra vulnerabilità, l’impossibilità di controllare l’oggetto del desiderio e del nostro amore, rimandano alla coscienza di sé, la cui comparsa non comporta solo «La sicurezza che l’io cosciente ha del suo essere qui», ma anche «la possibilità dell’insicurezza ontologica, ovvero il dubbio circa la realtà di questo essere […] e circa il suo perdurare nel tempo». Allora «La coscienza di sé introduce […] l’esperienza esistenziale della propria finitudine, ovvero della morte»24. Ecco, in una formula: la poesia serve solo la verità della condizione umana ed esistenziale nella sua ineliminabile insicurezza ontologica e nella sua differenza25. La condizione umana che caratterizza il soggetto è l’insicurezza ontologica in quanto egli oscilla tra determinatezza e indeterminatezza e la produzione artistica «deve essere considerata nella sua specificità anche come pura espressione della situazione esistenziale dell’uomo nella sua universalità»26.
Che l’arte e la poesia dicano delle verità tramite la finzione e la “menzogna” nulla toglie al loro carattere veritativo e al valore di quelle verità. Lo dice bene Catherine Coquio a proposito del delicato e controverso rapporto tra letteratura, testimonianza ed Auschwitz: «L’estetica e l’etica sono sempre state unite nell’atto poetico, anche nel più formalista. Se è naturale attribuire alla «finzione» e alla «poesia» dei poteri di deformazione del reale, condannarle per menzogna o barbarie presuppone o di limitare la «verità» al dominio dei «fatti», o di ignorare la natura del lavoro poetico e la sua capacità di veridicità soggettiva. / Un testo letterario non è il luogo dove il poeta abbellisce il reale, ma il luogo in cui la responsabilità passa attraverso la forma data al reale»27. Sempre l’arte e la poesia, anche attraverso la finzione, la “menzogna”, la maschera, le personæ, il camuffamento, esprimono una verità. Forse proprio questo carattere veritativo dell’arte e della poesia è esemplificato da Fernando Pessoa, il caso più estremo di personalità multipla e di io diviso della letteratura moderna, la cui sincerità aveva bisogno di camuffamenti e travestimenti, e – come dice in una sua lettera – di «esprimere una verità generale tramite una bugia personale»28.
Il poeta dice sempre qualcosa a proposito degli uomini, anche quando sembra parlare – o parla – d’altro, la sua arte è sempre allegorica: «Il poeta moderno magari «conta le striature del tulipano», e intanto pensa, anzi spera, di non aver fatto altro; ma che gli piaccia o no, ha detto qualcosa di nuovo sul conto dei fiori, e anche degli uomini»29. Naturalmente le verità umane a cui si allude (una qualsiasi verità umana, piccola o grande, positiva o negativa, moralmente riprovevole o encomiabile, politically correct o meno) nulla hanno a che fare con quelle dei giornali, dei media, del web, dei social, della politica o della scienza (del resto le ragioni dell’arte non sono le ragioni della politica o della scienza). Che ne è oggi delle verità teologiche, ideologiche, politiche, geografiche, fisico-astronomiche, scientifiche ecc. espresse dalla Commedia? Benché ne costituissero l’architettura, la struttura e l’impianto, difficilmente sono ancora valide e condivisibili. Quelle che invece hanno ancora valore per noi lettori del terzo millennio, che ancora ci coinvolgono ed emozionano, sono proprio le verità umane: tutta la ricca gamma dei sentimenti, degli affetti, dei desideri, delle gioie, dei timori, delle paure, delle angosce, delle sofferenze, delle debolezze, delle speranze, delle illusioni e delle disillusioni, delle passioni (anche politiche, anche religiose), tutti gli incontri e le relazioni umane, il rapporto con sé stessi, con gli altri, col mondo e con la natura, la tensione etica e metafisica, l’avventura spirituale e conoscitiva, la condizione umana, il bisogno di dare senso all’esperienza ecc. ecc.
Le poesie non sono semplici congegni linguistici, come a lungo abbiamo creduto in un secolo di formalismo, strutturalismo, semiotica, avanguardie, neoavanguardie e neo- neoavanguardie, ma sono potenti congegni emotivi. E le emozioni non sono forze cieche e irrazionali; anzi, l’intelligenza delle emozioni contribuisce a fondare il ragionamento etico. A stringere con più forza il nodo tra un capo e l’altro della poesia e dell’etica, per il tramite delle emozioni, è stata la filosofa americana Nussbaum, alla quale sta a cuore la rilevanza etica delle emozioni, il loro ruolo nel darci informazioni sulle questioni eticamente significative, il loro ruolo cognitivo e il fatto che esse ci rivelano la realtà etica. La posizione neo-stoica della Nussbaum recupera parte della riflessione degli stoici, almeno quella che sostiene che le emozioni sono forme di giudizio valutativo, quella che le considera come giudizi di valore; anche se poi essi affermano che questi giudizi sono falsi e che, pertanto, dobbiamo liberarcene. Nussbaum rifiuta questa visione normativa degli stoici, mentre ne salva l’analisi delle emozioni, convinta che, opportunamente modificata, «possa costituire la base per una concezione filosofica contemporanea delle emozioni»30.
La poesia contemporanea, come del resto l’arte tutta, nel suo processo di “disumanizzazione”31, ha subìto un impoverimento emotivo; la lirica moderna ha teso ad escludere l’emozione (“Del resto, non voglio nulla di umano” dichiarava Mallarmé nell’Hérodiade) e molti esiti odierni brillano proprio per la sua assenza. A proposito della poesia di Zanzotto, ma vale per buona parte degli autori contemporanei, scrive Giorgio Manacorda: «Ma, soprattutto, tutto è franato perché un edificio letterario non si tiene in piedi se non c’è la sostanza «emotiva» della poesia. La pura forma (anche a prescindere dal clima dell’epoca) non può che indurre al fallimento della negazione della forma»32. Eppure per alcuni l’emozione è ancora una guida possibile alla lettura del testo poetico: per Houellebecq, ad esempio, «non bisogna cercare la conoscenza di per se stessa. Tutto quello che non procede direttamente dall’emozione non ha in poesia nessun valore»33. Il ponte che collega le rive dell’arte a quelle dell’etica passa anche attraverso il fiume delle emozioni; sempre che la letteratura e la poesia non si riducano a puro laboratorio concettuale o non si vogliano spogliare di un loro magmatico nucleo emotivo. Il che significa anche gettare un ponte tra sfera emotiva e pensiero (etico o meno) se, come vuole Proust, le emozioni sono “sommovimenti geologici del pensiero”, se esse sono strettamente legate alla percezione e alla consapevolezza del valore e al giudizio etico, se esse sono dotate di intelligenza e di discernimento, se sono una parte costitutiva del sistema del ragionamento etico e non un’entità che interferisce con le nostre decisioni di agire secondo un sistema di princìpi colti dal freddo calcolo dell’intelletto.
La letteratura – secondo Nussbaum – costituisce una fonte privilegiata per l’elaborazione di un’adeguata teoria delle emozioni, poiché «certe verità sull’essere umano [possono] esser dette solo in forma letteraria»34. Il valore cognitivo della letteratura è tutt’uno col suo contenuto emotivo e passa – o dovrebbe passare – inevitabilmente attraverso le emozioni. Il contenuto emotivo di un’opera d’arte, letteraria e poetica è inscritto nel suo codice genetico, ovvero nella sua forma. La felicità della forma coagula il magma delle emozioni, che trovano così argine ed espressione. Sono indubbiamente da prediligere le opere ricche di contenuto emotivo, che passa attraverso la felicità della forma, il cui sensore che ne misura l’efficacia è la temperatura emotiva, la febbre che esse ci sanno inoculare. Le emozioni reattive – allora – come discrimine del valore di un’opera. Ovvio, poi, che un’opera non si riduca al suo solo contenuto emotivo, ma esso è la conditio sine qua non perché ricada nell’ambito dell’estetico. O abbiamo paura delle emozioni, di provare emozioni, o siamo – forse – emotivamente anestetizzati? La poesia nutre, cura e coltiva proprio le emozioni.
La cultura dell’edonismo coatto, della pubblicità e dello show, della spettacolarizzazione di ogni evento, del design industriale e dell’estetica della merce (marketing) ha – da una parte – sottratto all’arte il privilegio del godimento estetico, producendo sempre più arte priva di piacere. Dall’altra, nel presente storico del villaggio globale, della globalizzazione culturale, dellacondizione postmoderna e dell’ideologia del postmodernismo, l’estetica ha soppiantato l’etica, l’estetizzazione pervasiva e l’estetismo diffuso hanno sopraffatto verità e virtù: «si tratta – scrive Sergio Givone – dell’estensione progressiva (ed esclusiva) del paradigma estetico ai più diversi ambiti dell’esperienza»35. L’estetizzazione «si presta a dire il doppio movimento in questione. Quello che vede da una parte il modello estetico uscire dal proprio ambito e dilagare, imponendosi alle più diverse forme d’esperienza in modo esclusivo e contraddittorio, ma vede dall’altra la dimensione artistica sottrarsi al bello»36.
Dall’altra parte ancora, la condanna di Adorno ha finito per inibire la ricerca del piacere estetico in àmbito artistico, sentito come colpa e privilegio, come moralmente ingiusto e offensivo nei confronti dei milioni di morti della Shoah. È una contraddizione dolorosamente patita e vissuta dallo stesso Celan, il quale aveva chiara coscienza e consapevolezza del nodo “insolubile e paradossale” di bello estetico, piacere estetico e poesia eternatrice, che Giuseppe Bevilacqua riassume nei giusti termini: «Da un lato era evidente che l’argomento di derivazione adorniana era ineccepibile: il “bello estetico”, comunque sia realizzato, magari anche in controcanto, ossia autonegandosi nello stesso momento in cui si crea, attenua o addirittura oblitera l’orrore degli eventi storici più disumani, dal momento che il “bello estetico” è quanto di più umano vi sia. La stilizzazione poetica di un dolore indicibile lo rende funzionale a un piacere, ossia al suo contrario, alla sua negazione. […]. Dall’altro lato l’arte – nell’accezione più ampia del termine – è il mezzo di gran lunga più efficace per conferire perennità alla memoria di un fatto, e i fatti quanto più sono terribili tanto più chiedono a gran voce di non essere sepolti nella dimenticanza, chiedono insomma di essere, per quanto possibile, eternati nella memoria degli uomini»37. Tanto più quando il compito morale di cui il superstite si sente investito è quello di testimoniare, di parlare – come scrive Jean Cayrol nel primo verso di J’accuse – “Au nom du mort qui fut sans nom” per riscattarne la memoria e l’insensata morte. Accettare – senza riserve e senza vergogna – la presenza del piacere nell’arte non significa condividere la poetica dannunziana del piacere, dell’eroe esteta e decadente, del dandy e del superuomo, dell’art pour l’art o de il verso è tutto. Affermare che l’opera d’arte è un potente congegno emotivo non vuol dire lasciarsi andare alla deriva emotiva o subordinare la ragione alle emozioni, o proporre le stesse emozioni – positive o negative che siano – e i sentimenti, o peggio le stesse opere letterarie, come guida esclusiva e incontrollata dell’agire umano. Epperò, a proposito della letteratura, ha forse ragione Auden: «Il piacere è ben lungi dall’essere una guida critica infallibile: è però la meno ingannevole»38.
3. Una qualsiasi forma d’arte (poesia compresa), se è tale, non può essere misurata con i soli parametri della verità e della realtà storica, fosse anche quella terribile della Shoah, che non può godere – in questo senso – di uno statuto speciale o di una sua intoccabile giurisdizione, per quanto si sia consapevoli della sua “unicità”; ecco perché appaiono alquanto pretestuose le polemiche e le critiche da parte degli storici, anche di quelli meglio intenzionati, ai romanzi, alle poesie, ai racconti, alle opere musicali, ai film ecc. – insomma a tutte quelle espressioni artistiche che si basano sulla “finzione” – che hanno a che fare con l’Olocausto. Polemiche e critiche che hanno anche coinvolto, negli ultimi anni, il bellissimo film di Roberto Benigni La vita è bella (1997) o il romanzo di Jonathan Little Les bienveillantes del 2006 (Le benevole, 2007). Ammesso e non concesso che l’arte prodotta in lager (musica, poesia, disegno, teatro ecc., di cui resta ampia testimonianza) o fuori sul lager, dai testimoni e dai sopravvissuti o da chiunque, sconvolto da quanto di disumano lì accaduto – come Arnold Schönberg – ha voluto confrontarsi, con il linguaggio dell’arte, col male – se non assoluto – radicale, non siano adeguate a dire l’indicibile, a rappresentare l’irraprensentabile, ad attestare l’inattestabile.
Ma già subito dopo la guerra, Un sopravvissuto di Varsavia, “oratorio per voce recitante, coro maschile e orchestra” composto da Schönberg nel 1947, venne fortemente e duramente criticato proprio da Adorno: «Ma perfino Il sopravvissuto di Varsavia resta prigioniero dell’aporia cui esso, configurazione autonoma dell’eteronomia potenziata a inferno, si abbandona senza ritegni. Alla composizione di Schönberg si accoppia un elemento penoso. […] poiché esso, nonostante tutta la durezza e l’inconciliabilità, viene fatto immagine, allora è come se il pudore nei confronti delle vittime venisse ferito. Ci si serve di queste per preparare qualcosa, opere d’arte gettate in pasto al mondo che le ammazzò. La cosiddetta configurazione artistica del nudo dolore fisico di chi veniva abbattuto a colpi di calcio di fucile contiene, per quanto alla lontana, il potenziale di estorce il godimento. La morale, che comanda all’arte di non dimenticarla nemmeno per un secondo, sdrucciola nell’abisso del suo contrario. Attraverso il principio estetico di stilizzazione e addirittura poi tramite la solenne preghiera del coro, l’inimmaginabile destino appare come se avesse avuto un qualche senso; viene trasfigurato, un po’ del suo orrore viene eliminato; e già solo per questo non si rende giustizia alle vittime mentre davanti alla giustizia non reggerebbe alcuna arte che eviti le vittime. Anche il suono della disperazione paga il suo tributo alla sciagurata affermazione»39.
Discutibile o meno, condivisibile o meno è comunque dalla provocatoria tesi di Adorno, pronunciata nel 1948 – a ridosso della chiusura dei campi di sterminio – e pubblicata nel ’51, che occorre partire per una riflessione sulla possibilità/impossibilità della poesia o, meglio, da Auschwitz e dall’univers concentrationnaire: ai confini dello spirito, stabiliti e segnati dalla realtà del lager – laddove «lo spirito s’imbatteva nei limiti che gli erano posti» – «La bellezza era un’illusione. La conoscenza si rivelava un gioco sui concetti. La morte si celava dietro tutta la sua inconoscibilità»40. Da questo azzeramento, da questo degré zero dell’umano occorre ripartire.

Scriveva dunque Adorno: «La critica della cultura si trova dinanzi all’ultimo stadio della dialettica di cultura e barbarie: scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie, e ciò avvelena la stessa consapevolezza del perché è divenuto impossibile scrivere oggi poesie»41. Nella conferenza radiofonica del ’62, Impegno, ribadiva: «Non vorrei attenuare una cosa da me detta, cioè che è da barbari scrivere ancora lirica dopo Auschwitz», pur accogliendo la giusta replica di Enzensberger secondo cui «la poesia deve appunto tener testa a questo verdetto, essere dunque tale da non consegnarsi al cinismo seguitando semplicemente a esistere dopo Auschwitz»42.
Interdetto – del resto – rivisto, attenuato e integrato dallo stesso Adorno in più occasioni, accogliendo anche la risentita protesta di Celan: «forse è falso avere detto che dopo Auschwitz non si può più scrivere una poesia. Invece non è falsa la questione se dopo Auschwitz si possa ancora vivere, se specialmente lo possa chi vi è sfuggito per caso e di norma avrebbe dovuto essere liquidato»43. Qualche anno dopo, nel ’67, Adorno mitigherà ulteriormente il suo divieto: «Il dire che dopo Auschwitz non si possono più scrivere poesie non ha validità assoluta, è però certo che dopo Auschwitz, poiché esso è stato possibile e resta possibile per un tempo imprevedibile, non ci si può più immaginare un’arte serena»44. Probabilmente le ultime parole di Adorno in proposito, che riprendono il discorso e il filo di una riflessione mai interrotta sul dopo-Auschwitz, per cui forse non esiste neppure per la poesia una parola definitiva, sono quelle pronunciate nella postuma Teoria estetica, laddove si dice che la lirica di Celan «è compenetrata dalla vergogna dell’arte al cospetto del dolore che si sottrae, sia all’esperienza, sia alla sublimazione. Le poesie di Celan vogliono dire col silenzio l’estremo orrore. Il loro stesso contenuto di verità diventa un fatto negativo. Esse imitano una lingua al di sotto di quella impotente degli uomini, anzi di ogni lingua organica, imitano la morta lingua della pietra e della stella»45.
La provocazione di Adorno credo vada interpretata alla luce delle sue successive “correzioni” e chiarificazioni, in primis quelle avanzate in Impegno (1962), anche se egli dice di non voler attenuare quanto precedentemente detto sulla barbarie di scrivere poesie dopo Auschwitz. In questo saggio Adorno, per far comprendere la sua posizione, si rifà a quanto chiede un personaggio della pièce di Sartre Morts sans sépulture, scritta nel 1941: «“Ha senso vivere quando ci sono uomini che picchiano finché le ossa si frantumano?”; ciò è anche chiedere se è in generale ancora consentito all’arte di esistere, se la regressione spirituale nel concetto di letteratura impegnata non sia intimata dalla regressione della società stessa»46. Ecco, io credo che Adorno avrebbe potuto, a sua volta, più che enunciare un provocatorio verdetto, per farsi meglio intendere, porre una domanda: è un atto di barbarie scrivere poesia dopo Auschwitz? Oppure: “è in generale ancora consentito all’arte di esistere”? Anche perché, pur forse suonando retorico l’interrogativo, il centro della discussione avrebbe così potuto ruotare intorno al fatto che la poesia, dopo la Shoah, non può, non tanto esistere, quanto seguitare “semplicemente” ad esistere come se nulla fosse accaduto.
Anche perché il discorso di Adorno non si arresta qui: egli riconosce che «È la sua situazione a essere paradossale e non soltanto il modo di rapportarsi a essa. La smisurata sofferenza reale non tollera oblii; il detto teologico di Pascal “On ne doit plus dormire” va secolarizzato»47; ed è proprio quella sofferenza, aggiunge Adorno, che paradossalmente e dialetticamente, pur inibendo l’arte, «richiede anche il perdurare dell’arte, che pur proibisce; in nessun’altra sede, praticamente, la sofferenza trova ancora una voce a essa propria, la consolazione che non la tradisca ipso facto. Gli artisti più significativi della nostra epoca hanno seguito quest’ottica. L’intransigente radicalismo delle loro opere, proprio i momenti proscritti sotto l’accusa di formalismo, dà loro la terribile forza che manca alle ingenue poesie sulle vittime»48. Ovvia, qui, la predilezione di Adorno non per la “letteratura impegnata” quanto per “l’astrattezza dell’avanguardia” artistica (Beckett ad esempio, o anche Kafka) e per le “opere autonome” e la loro oltranza linguistica e formale. Ma è anche ovvia – a mio modo di vedere – la risposta implicita alla sua stessa domanda: l’arte e la poesia non solo esistono e continuano ad esistere, pur contraddittoriamente e paradossalmente, ma – non dimenticando Auschwitz e mantenendo desto lo spirito perché la sofferenza non tollera la dimenticanza – sono anche l’ultimo ricettacolo della sofferenza stessa, a cui danno propriamente voce.
La sentenza di Adorno, comunque la si voglia intendere e variamente interpretare, ha il merito di considerare Auschwitz «uno spartiacque decisivo perché l’evento disumanizzante che vi si è consumato ha l’effetto di aver messo fuori gioco il regime rappresentativo della modernità e, più precisamente, la sua piena familiarità con la presentazione dell’irrapresentabile e con la funzione poietica dell’arte». Egli considera Auschwitz «un fatto storico che va a incidere direttamente e irreversibilmente sullo statuto della rappresentazione e del piacere estetico, i quali debbono sapersi ripensare sul piano di un’etica della forma»49. Con le tesi estreme di Adorno hanno dialogato, per confrontarsi o per aggirarle, le estetiche del secondo dopoguerra: quella di orientamento marxista, quella di tipo scientifico e analitico, l’estetica fenomenologica, l’estetica teologico-politica, quella ermeneutica ecc. Al di là delle diverse posizioni e dell’eterogeneità delle risposte, dalle quali non è lecito ricavare una comune proposta, tutte – comunque – tendono a sottolineare la valenza etica dell’arte, gli aspetti etici dell’esperienza estetica e la responsabilità della forma. Così come va dato merito ad Adorno, con la sua sentenza inappellabile e ineludibile, di aver voluto preservare il male estremo, assoluto, radicale dalla banalizzazione e l’orrore dall’estetizzazione, di aver voluto prevenire il rischio – in parte oggi realmente corso – che il ricordo di Auschwitz venisse, come dice Kertész, “ritualizzato, strumentalizzato, reso astratto”.
Al divieto adorniano, da molti contestato e dai più disatteso, si affiancarono coloro che negavano alla letteratura la possibilità tout court di rappresentare e raccontare l’Olocausto. George Steiner invitava, in Linguaggio e silenzio (1967, 1972), proprio al silenzio per non aggiungere all’indicibile la chiacchiera e le banalità del dibattito letterario e sociologico, inaugurando così la “scuola del silenzio” negli studi anglosassoni sulla letteratura della Shoah. Elie Wiesel, con la sua oracolare sentenza («Un romanzo su Auschwitz non è un romanzo o non è su Auschwitz»50), forniva un autorevole esempio di negazione della letteratura e del letterario. Lanzmann, autore del film Shoah (1985), condannava tutta la fiction in quanto genere consolatorio, tanto da diventare il suo divieto – come è stato detto – un’altra “tavola della legge”. Tanto l’interdetto di Adorno quanto formule liquidatorie come quella di Wiesel sono state, con altrettante lapidarie formule, criticate e condannate; alcune a caso fra le tante, tra loro quasi equivalenti nel rovesciare l’imperativo categorico del filosofo della Scuola di Francoforte, seppure con decisive sfumature: «Dopo Auschwitz si può fare poesia solo sulla base di Auschwitz» (Peter Szondi)51; «dopo Auschwitz non si può fare poesia se non su Auschwitz» (Primo Levi in una famosa intervista e, a rinforzo: «A dispetto di Adorno, non solo si possono ancora fare poesie dopo Auschwitz, ma su Auschwitz stesso si possono, o forse si debbono, fare poesie»52); «a casa mi attendeva un compito: fare poesia dopo Auschwitz» (Tadeusz Rosewicz)53; «dopo Auschwitz si possono scrivere poesie solo su Auschwitz» (Imre Kertész)54; «dopo Auschwitz si può scrivere solo di Auschwitz» (Pier Vincenzo Mengaldo)55 ecc.
È legittimo chiedersi se l’arte, la letteratura e, in particolare, la poesia siano idonee a trattare un fatto storico come la Shoah (del resto dell’insufficienza dei mezzi espressivi, della mancanza delle parole, del pericolo di deformare la realtà e di sublimare l’orrore attraverso la scrittura si resero subito conto gli stessi testimoni); ma è altrettanto lecito rispondere che «di fronte a un evento che sfida la ragione, la poesia è forse il mezzo più adeguato per esprimere l’inconcepibile, l’indicibile»56 e che chi tende ad opporre letteratura ed Olocausto finisce per delegittimare Auschwitz. Sulle possibilità della fiction romanesque di rappresentare la Shoah valgano per tutte le condivisibili posizioni dei testimoni e sopravvissuti Jorge Semprún e Imre Kertész. Anzi, quest’ultimo pone la questione in termini altrettanto radicali: «Il vero problema […] è la fantasia, l’immaginazione. Anzi, per essere più precisi, quanto l’immaginazione sia capace di elaborare, di assimilare il dato di fatto dell’Olocausto e quanto l’Olocausto grazie all’immaginazione ricettiva sia diventato parte della nostra quotidianità etica, della nostra cultura etica. Perché si tratta di questo, e se dobbiamo parlare di letteratura ed Olocausto, dobbiamo parlare di ciò»57. Per Kertész noi «possiamo crearci un’idea dell’Olocausto solo grazie alla forza dell’immaginazione estetica» perché «i nudi fatti ci forniscono soltanto montagne di cadaveri», per cui – semmai – la domanda cruciale è: «quanto è riuscito lo spirito estetico, la stessa letteratura, a creare una rappresentazione rilevante dell’Olocausto?»58.
«Stanno davanti a me, con gli occhi sbarrati, e d’improvviso io mi vedo nel loro sguardo di terrore: nel loro sgomento» e, appena dopo, «Mi guardavano, con gli occhi impauriti, pieni di orrore»: è l’incipit folgorante e commovente de La scrittura o la vita, la reazione dei tre ufficiali in uniforme britannica di fronte al deportato Jorge Semprún alla liberazione del campo. E subito Semprún si chiede: «Ma si può raccontare tutto ciò? Si può? Il dubbio mi sorge fin da questo primo istante. È il 12 aprile 1945, il giorno dopo la liberazione di Buchenwald»; e insiste: «tuttavia mi sorge un dubbio sulle possibilità di raccontare». Ma altrettanto rapida arriva la risposta: «Soltanto coloro che sapranno fare della loro testimonianza un oggetto artistico, uno spazio di creazione, o di ricreazione, riusciranno a raggiungere questa sostanza, questa densità trasparente. Soltanto l’artificio di un racconto abilmente condotto riuscirà a trasmettere in parte la verità della testimonianza»59. Per Semprún «L’essenziale è riuscire ad andare oltre l’evidenza dell’orrore per tentare di raggiungere la radice del Male radicale. Perché l’orrore non era il Male, o almeno non era la sua essenza. L’orrore non era altro che l’addobbo, l’ornamento, l’apparato. L’apparenza, insomma. Si sarebbero potute passare delle ore a fornire testimonianze sull’orrore quotidiano, senza sfiorare l’essenziale dell’esperienza della vita nel campo»60. L’essenziale, insomma, non è l’enumerazione delle sofferenze, accumulare nel dettaglio, computare uno dietro l’altro – quantitativamente – i terribili orrori quotidiani elencandone all’infinito i particolari (e lo si può fare, e lo si deve fare), l’essenziale è l’esperienza del male (l’inumano nell’uomo, l’inumanità dell’uomo), il kantiano Male radicale (das radikal Böse), quella “cruciale”, “totale” del lager che “avrà invaso e divorato ogni cosa”. Ma l’essenziale di questa esperienza del male sarà, anche, l’essere stata vissuta come esperienza della morte, l’aver vissuto la morte come esperienza collettiva e fraterna, capace di fondare l’essere-insieme.
Durante una discussione tra deportati a Buchenwald, appena dopo la liberazione del campo, viene sollevato il problema di come si dovrà raccontare perché si possa essere capiti, sempre che esista la volontà di ascoltare: ebbene, per Semprún raccontare bene in modo da essere capiti «non sarà possibile senza un minimo di artificio. Quanto basta perché il racconto diventi arte!». Proprio perché la verità da raccontare è difficilmente credibile, addirittura inimmaginabile, occorre suscitare l’immaginazione dell’inimmaginabile grazie all’artificio. A sostegno della sua tesi interviene un altro deportato, un professore dell’Università di Strasburgo: «Immagino che ci saranno molte testimonianze… varranno quanto varrà lo sguardo del testimone, la sua intensità, la sua perspicacia… E poi ci saranno dei documenti. Più tardi, gli storici raccoglieranno, riuniranno, analizzeranno le une e gli altri: ne faranno delle opere dotte… Sarà detta, registrata, ogni cosa…
Tutto risponderà al vero… solo che mancherà la verità essenziale, quella verità che nessuna ricostruzione storica, per perfetta e onnicomprensiva che sia, potrà mai raggiungere…»; essa potrà essere detta «Attraverso l’artificio dell’opera d’arte»61. Insomma, il manzoniano “vero poetico” integra e invera il “vero storico”. Ancora recentemente Raffaele La Capria ha formulato una poetica che potremmo definire manzoniana: «Non ci basta sapere, come dice la storia, che Troia fu assediata per dieci anni e poi distrutta dai greci. Ci interessano di più le passioni degli eroi che combatterono sotto le sue mura. L’ira di Achille, la virtù di Ettore, l’astuzia di Ulisse. E questo lo dice la letteratura. C’è perfino chi sostiene che la guerra di Troia è avvenuta soltanto quando Omero l’ha cantata o, addirittura, «perché Omero la cantasse» nei suoi versi. / Cesare fu ucciso da Bruto, Cassio e gli altri congiurati sotto la statua di Pompeo, con ventidue pugnalate. Questa è la Storia. Cosa passò nella mente di Cesare quando vide lampeggiare i pugnali, quali erano i sentimenti di Bruto mentre trafiggeva l’amico, quali rimorsi assalirono lui e Cassio dopo, con quali parole Antonio incitò l’animo dei romani alla rivolta, questo è la letteratura, è la potente immaginazione di Shakespeare, a farcelo rivivere. E così Napoleone fu sconfitto nella battaglia di Waterloo, è storia: cosa vuol dire trovarsi in una battaglia di quella portata senza nemmeno accorgersi di quello che avviene, di chi è il vinto e chi il vincitore, è Fabrizio del Dongo a dircelo nelle pagine iniziali della Certosa di Parma. E questa è letteratura»62.
Da sempre il poeta – da Dante a Levi – si è trovato di fronte al problema di comunicare l’incomunicabile, di attestare l’inattestabile, di esprimere l’inesprimibile, di catturare l’ineffabile, sempre si è misurato con il limite, con l’inadeguatezza, con l’insufficienza della parola poetica, face all’“alta vision” o alla Shoah o al proprio profondo sentire («Lingua mortal non dice / quel ch’io sentiva in seno»). Ma Dante, dicendo insistentemente che non può – per un difetto di memoria – ricordare e dire dell’avvenuta visione e contemplazione di Dio («[…], e vidi cose che ridire / né sa né può chi di là su discende» (Paradiso, Canto I, vv. 5-6), dicendo che gli manca la parola («Omai sarà più corta mia favella, / pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante / che bagni ancor la lingua alla mammella», Paradiso, Canto XXXIII, vv. 106-108), insistendo sulla sua inadeguatezza («Oh quanto è corto il dire e come fioco / al mio concetto! e questo, a quel ch’i’ vidi, / è tanto, che non basta a dicer ‘poco’» (vv. 121-123) e sull’insufficienza della parola umana di fronte all’altezza della visione («Da quinci innanzi il mio veder fu maggio / che ’l parlar nostro, ch’a tal vista cede» (vv. 55-56), in fondo non fa altro che parlarci di Dio, che porci innanzi proprio all’«alta luce che da sé è vera» (v. 54), all’alta visione della verità e all’essenza divina. La consapevolezza del “limite” della parola poetica non si traduce mai in Dante in resa all’impossibilità di comunicare, anzi si alimenta del contrasto fra la “maestà superba del tema” e la presa d’atto dell’insufficienza “ad esprimerla con umane parole”, stimolando “un ulteriore sforzo”, “uno slancio più vasto” (Sapegno), spingendo
sempre più in là il limes del proprio dire. Egli ci invita a immergere lo sguardo fiso in quel “lume riflesso” in cui «dentro da sé, del suo colore stesso, / mi parve pinta della nostra effige» (vv. 130- 131). Forse anche per questo Levi amava Dante: di fronte all’inaudito il sommo poeta gli proponeva di confrontarsi con la necessità di ricordare e con l’imperativo morale – malgré tout – di comunicare: «Negare che comunicare si può è falso: si può sempre. Rifiutare di comunicare è colpa»63.
Image: Die Jagd nach dem Glück | Rudolf Friedrich August Henneberg | 1892
Note:
1 Vittorio Sereni, Niccolò in Id., Stella variabile, Milano, Garzanti, 1981. Poi in Id., Poesie, a cura di Dante Isella, Milano, Mondadori, 1995. Inoltre: Id., Stella variabile, Prefazione di Fabio Pusterla, Torino, Einaudi, 2010.
2 Giovanni Raboni, Ah no, non a un filo soltanto in Id., Ogni terzo pensiero, Milano, Mondadori, 1993. Poi in Id., Tutte le poesie 1949-2004, a cura di Rodolfo Zucco, Parte I e Parte II, Torino, Einaudi, 2014.
3 Franco Crespi, Crisi e rinascita dell’utopia, Introduzione a Lewis Mumford, Storia dell’utopia, Roma, Donzelli, 2008, p. XIII.
4 Cfr. Ernst Bloch, Il principio speranza, (1959), 3 voll., Milano, Garzanti, 1994.
5 Cfr. Giuseppe Zoppelli, Utopia della poesia. Le parole sepolte, Pasturana (AL), puntoacapo Editrice, 2015.
in ilgiardinodeipensieri.eu. URL
6 Cit. da 7 Mario Trombino, L’isola che non c’è: i volti dell’utopia da Platone ad oggi consultato il 30 marzo 2014.
cit. 8 Herbert Marcuse, Eros e civiltà, (1955), Torino, Einaudi, 1980 (1964), p. 204.
9 Alberto Casadei, Poesia e ispirazione, Roma, Luca Sossella Editore, 2009, p. 12. 10 Ibid., p. 15.
11 Ibidem.
12 Ibid., p. 18. Mario Trombino, L’isola che non c’è: i volti dell’utopia da Platone ad oggi
13 Ibid., pp. 25-26.
14 Seamus Heaney, La riparazione della poesia. Lezioni di Oxford, Roma, Fazi, 1999, p. 30.
15 Costantino Kavafis, Poesie segrete, Milano, Crocetti Editore, 1985.
16 Michael Hamburger, La verità della poesia. Da Baudelaire a Montale, (1969, 1982), Bologna, il Mulino, 1987, p. 43. 17 Bertolt Brecht, Dalla critica dell’opera «culinaria» alla riabilitazione del godimento estetico in Pietro Montani (a cura di), L’estetica contemporanea. Il destino delle arti nella tarda modernità, Roma, Carocci, 2004, p. 48.
18 Cit. da Riccardo Morello, Commemorare e dimenticare. La lirica di Paul Celan in Alberto Cavaglion (a cura di), Dal buio del sottosuolo. Poesia e Lager, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 68-69.
19 Michael Hamburger, La verità della poesia. Da Baudelaire a Montale cit., p. 29.
20 Ibid., p. 32.
21 Cit. da Giovanni Greco – Davide Monda, Introduzione a Id. (a cura di), Miserabili in poesia, Roma, Carocci, 2002, p. 10.
22 Martha C. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, (2001), Bologna, il Mulino, 2004, p. 300.
23 Ibidem.
24 Franco Crespi, Le vie della sociologia, Bologna, il Mulino, 1985, p. 21.
25 «L’oscillazione tra determinato e indeterminato può essere indicata con il termine differenza, non intendendo quindi quest’ultima come il contrario dell’identità, ma come il rapporto tra identità (la determinatezza) e non identità (l’indeterminatezza): dal momento che tale rapporto avviene nella coscienza, questa può essere definita il luogo della differenza» (ibid., p. 30).
26 Ibid., p. 423.
27 Catherine Coquio, Finzione, poesia, testimonianza: dibattiti teorici e approcci critici in Marina Cattaruzza – Marcello Flores – Simon Levis Sullman – Enzo Traverso (a cura di), Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del xx secolo, volume II, La memoria del XX secolo, Torino, Utet, 2005, p. 566.
28 Cit. da Michael Hamburger, La verità della poesia. Da Baudelaire a Montale cit., pp. 174-175.
29 Ibid., p. 26.
30 Martha C. Nussbaum, Introduzione alla nuova edizione in Id., La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca, (1986, 2001), Bologna, il Mulino, 2004 (1996), cit., pp. 5-6.
31 Ortega y Gasset (La deshumanización del arte, 1925), non poteva sapere che il termine “disumanizzazione” si sarebbe storicamente incarnato, vent’anni dopo il suo saggio, in quel processo di disumanizzazione e di demolizione in lager a cui erano costretti i deportati; ma certo a noi oggi esso appare per sempre compromesso con l’universo concentrazionario e con la Shoah, creando un inquietante cortocircuito tra i fenomeni dell’arte e della società.
32 Giorgio Manacorda (a cura di), La poesia italiana oggi. Un’antologia critica, Roma, Castelvecchi, 2004, p. 489.
33 Cit. da Roberto Galaverni, Il poeta è un cavaliere Jedi. Una difesa della poesia, Roma, Fazi Editore, 2006, p. 41. 34 Martha C. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni cit., p. 19.
35 Sergio Givone, Prima lezione di estetica, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 49.
36 Ibid., p. 85.
37 Giuseppe Bevilacqua, Eros, Nostos, Thanatos: la parabola di Paul Celan, introduzione a Paul Celan, Poesie, Milano, Mondadori, 1998, p. XXXVI.
38 Wystan Hugh Auden, La mano del tintore, (1948), Milano, Adelphi, 1999, p. 17.
39 Theodor W. Adorno, Impegno (1962) in Id., Note per la letteratura 1961-1968 cit., p. 103.
40 Jean Améry, Intellettuale a Auschwitz, (1966, 1977), Torino, Bollati Boringhieri, 1988 (1987), pp. 52 e 54.
41 Theodor W. Adorno, Critica della cultura e società (1949) in Id., Prismi. Saggi sulla critica della cultura, Torino, Einaudi, 1972, p. 22.
42 Theodor W. Adorno, Impegno (1962) in Id., Note per la letteratura 1961-1968 cit., p. 102.
43 Theodor W. Adorno, Dialettica negativa, (1966), Torino, Einaudi, 2004 (1970), p. 326.
44 Theodor W. Adorno, È serena l’arte? (1967) in Id., Note per la letteratura 1961-1968 cit., p. 277.
45 Theodor W. Adorno, Teoria estetica, (1970), Torino, Einaudi, 1975, p. 538.
46 Theodor W. Adorno, Impegno (1962) in Id., Note per la letteratura 1961-1968 cit., p.102.
47 Ibidem.
48 Ibid., p. 103.
49 Pietro Montani, Introduzione a Id. (a cura di), L’estetica contemporanea. Il destino delle arti nella tarda modernità, Roma, Carocci, 2004, cit., p. 20.
50 Elie Wiesel, Un ebreo oggi. Racconti, saggi, dialoghi, (1977), Brescia, Morcelliana, 1985, p. 214.
51 Peter Szondi, Lettura di «Stretto». Saggio sulla poesia di Paul Celan, (1971), in Id., L’ora che non ha più sorelle. Studi su Paul Celan, Ferrara, Gallio, 1990, p. 60.
52 Giancarlo Borri, Le divine impurità. Primo Levi tra scienza e letteratura, Rimini, Ed. Luisè, 1992, p. 72.
53 Cit. da Sascha Feuchert, “Inchiodata è la mia lingua…”. Alcune considerazioni sulla lirica dell’Olocausto nata dentro e dopo i campi di concentramento in Alberto Cavaglion (a cura di), Dal buio del sottosuolo. Poesia e Lager cit., p. 60.
54 Imre Kertész, La lunga ombra scura in Id., Il secolo infelice, Milano, Bompiani, 2007, p. 48.
55 Pier Vincenzo Mengaldo, La vendetta è il racconto. Testimonianze e riflessioni sulla Shoah, Torino, Bollati Boringhieri, 2007, p. 118.
56 Daniela Amsallem, “Au nom du mort qui fut sans nom”. La poesia del Lager in Francia in Alberto Cavaglion (a cura di), Dal buio del sottosuolo. Poesia e Lager cit., p. 29.
57 Imre Kertész, La lunga ombra scura in Id., Il secolo infelice cit., p. 47.
58 Ibid., p. 49.
59 Jorge Semprún, La scrittura o la vita, (1994), Parma, Guanda, 2005 (1996), pp. 11, 19, 20.
60 Ibid., p. 86.
61 Ibid., pp. 118, 119, 120.
62 Raffaele La Capria, Il sentimento della letteratura, Milano, Mondatori, 1997, pp. 16-17.
63 Primo Levi, I sommersi e i salvati in Id., Opere, Volume primo, Torino, Einaudi, 1987, p. 721.





