
Talarico | Leggendo Mnemosyne
Negli abissi mortali: leggendo Mnemosyne di Michele Montorfano
Muoversi dalla storia è sempre difficile; quando questa è mondiale (o di pubblico dominio) ancor di più. Non resta allora che prenderla a spunto, pretesto, per poi spersonalizzarla in un sistema assoluto e comune di segni, in un linguaggio delle nervature, fino ad immaginare ciò che forse Montorfano ci suggerisce tra le righe: un poliglottismo della e nella morte, dove «la grafia è universale / mentre si scolano i copri, / li si lasciano appesi ad asciugare» (XXVII).
Ma di storico c’è solo il dolore. È attraverso la sua costante che si rivisita quindi una storia senza più date e luoghi, una continuità che «dal punto di origine del fossile / al muro universale della specie» (XIV), non concede qui spazi per facili giudizi o lezioni di morale. E lo stesso autore sembra darcene conferma, quando in seguito a una breve dichiarazione, sottolinea il suo compito di cronista imparziale: «Non esiste altro amore in questo posto che morda il fondo della pagina. // Io scrivo i nomi degli orchi accanto a quelli dei santi. // Scrivo che le cose si consumano; che la neve è tutto / e che la notte è passata tra le sue querce»(XXXII).
Egli osserva, e diviene vittima e carnefice. Incide, viviseziona, scruta sotto i lembi di pelle. Al contempo ha quindi il ruolo del narratore, ma è anche la mano che opera e la carne che si apre. E tutto questo senza mai un fiato, una smorfia di dolore, né un accenno di soddisfazione. Al contrario, nell’accanimento, si denota al massimo un non so quale affanno d’impotenza, proprio del masochista e ancor più del sadico. Ma lo possiamo solo supporre. La sua scrittura è sguardo impenetrabile.
Si entra o ci si prepara pertanto a una dimensione di appiattimento emotivo, dove «non c’è nulla nella pancia dello squalo. / Solo due bestie che si scannano oltre morte / prendendo la morte che respira sulla vita» (VII). Ma affinché un uomo normale, almeno quanto ognuno di noi, possa fare (e lo ha fatto e lo continuerà a fare) determinate azioni, bisogna che si auto imponga delle differenze di livello tra un io (non-carnefice, ma uomo, soggetto) e l’oggetto (non-vittima) che si ha di fronte, per far sì che il gesto compiuto non appaia col suo carico di responsabilità, come omicidio, tortura, ma dovere, giustizia, sacrificio, pulizia, o scienza.
Sin dal primo componimento infatti ci si trova di fronte alla disumanizzazione della persona. Questa non è più un nome, né ha volto, ma, scorporata, diviene «muso», un ammasso estraibile «da un buco» come fosse una bestia nella sua tana (XXX). Non c’è spazio per l’essere umano nella sua integrità, ma solo per le sue parti: i pezzi che lo compongono (abbondano «colli», «braccia», «bocche», «capelli», «cartilagini», «unghie», «tibie»), al massimo possono essere elevati al rango di corpo. Un uomo spersonalizzato risulta perciò più prossimo a essere una missione, una ricerca asettica, piuttosto che un essere vivente: «Ogni cosa qui / è un angolo di niente. / Anche questo cuore è zona, / è polpa che si esplora» (pp. 55).
Quando tra le pagine infatti appare una «donna» è quantomeno figura inaspettata; ma ecco allora che prima ancora di immaginarla in qualità umane, immediatamente (anzi, precedentemente) viene riportata con «zampe» ad un macchinario ambulante di sesso femminile. È il già accennato processo di declassamento: «Dove c’erano i capelli ora / è una tolda aperta che scricchiola tra le gomme, / un pronome esorbitato / dal talamo al fango» (XXXI). Mentre per contro ci si può imbattere nel processo inverso, secondo il quale la parte viene umanizzata: avremo così una vena, che piange tra le dita (XVIII).
Nell’impero della carne infatti, si arriva fino ad assurgere il corpo a soggetto, deformandolo a invasore-conquistatore dell’anima, resa e piegata a suo strumento (XI). Il corpo come relitto e testimonianza (XIII) di Montorfano rimanda, più che ai reportage di guerra e di denuncia, agli scatti di Joel-Peter Witkin (si confronti la fotografia The kiss con il componimento XII del libro in questione), anche se risulta poi del tutto slegato dalla staticità e dai fini meramente estetici delle composizioni del fotografo. L’autore, pur nell’immobilità, osserva i corpi in divenire, ne trascrive l’ultimo respiro, il contorcersi delle nervature, sia pure che questo divenire significasse un congelarsi protratto nell’eternità.
Comprensibilmente, in questo panorama, quando non completamente assente, il paesaggio è desolato o apocalittico. Solo rami nudi come scheletri, atmosfere temporalesche o impolverate di neve. Persino gli scopi, con gli strumenti a cui normalmente sarebbero associati, subiscono un rovesciamento tale che l’energia sprigionata dal contrasto, erompe con violenza tra i versi (vedremo per es. nel componimento XIVun martello, strumento violento e possente, cui spetterà il macabro compito di precisione dell’ ago da cucito).
La spersonalizzazione dell’essere vivente trova dunque eco nell’opera stessa, e come già evidenziato da altre recensioni, ad eccezione di alcuni testi, quest’ultima appare del tutto non privata, impersonale. Il registro di Mnemosyne (LietoColle, 2013) è dunque costante, ma più che monòtono (come si afferma nella bella prefazione di Santagostini) ci sembra monotòno. La tensione non allenta e non strattona. L’autore resta nella porzione geografica che gli si confà: a un palmo dalla carne e a uno nella carne. — Il focus però, come vedremo più avanti, cambia il suo obiettivo.
Il tono è da verbale, eccetto alcuni lampi di poesia comunemente intesa, preferisce un registro se non scientifico, quantomeno anatomico, analitico. Tra queste pagine non c’è spazio per la «chose envolée» di Verlaine. E pur conoscendo un altalenarsi tra pragmatismo ed elucubrazione mentale, il suo verso resta sempre esatto, asciutto, chiaramente circoscritto. Ciononostante in Montorfano, seppure più funzionale che estetica, c’è un’interessante attenzione al suono, che si concentra maggiormente nelle chiusure attraverso rime, allitterazioni, assonanze, consonanze e rimandi sonori («impianto-guanto», «grucce-luce», «ferita-fatica», «fondono-mondo», «punte-finalmente», «zona-esplora», «subordina-preordina», «mollica-vita-ferita», e così via). Eppure, a dispetto di ciò, forse qui non si ha nulla di più lontano da una scrittura che esiga la declamazione, o che si presti volentieri anche solo a una lettura ad alta voce. Né la poesia di Montorfano sembra lontanamente essere il fine. È piuttosto il giusto, più che naturale mezzo, attraverso il quale muovere un volume di informazioni simile.
Alla non frequentissima potenza del singolo verso, l’autore contrappone la compattezza e l’unitarietà dell’opera. È difficile enuclearne le parti, né c’è un solo mattone che abbia la pretesa di essere edificio. Sembra che regni una grande disciplina tra queste pagine, affinché possa essere sorretto il peso intero della struttura. Raramente infatti una poesia inizia a sé, ma come riprendendo il filo di un discorso invisibile, la cui parte iniziale ci è oscura o è il libro intero. La sua poesia non è dunque isolabile, non se ne possono fare delle pillole, aforismi da copia-incollare nel web. Bisogna leggerla nella sua interezza, entrare nella dimensione che essa pretende.
Ciò che inoltre piacevolmente stupisce di questa Opera prima è che, se da un lato essa risulta chiaramente spregiudicata, a modo suo sconveniente, cruda (sin dalla scelta dei termini, delle immagini: «occhi ustionati», «fracasso d’aghi», «ferita che squittisce», «vasca di carne», «matassa di nervi», ecc.), dall’altro non s’avverte invece la minima intenzione (né propensione) da parte dell’autore a essere scioccante, a far chiasso intorno a sé. È una scrittura maniacale, è vero, ma pacata, rispettosa ed educata. Nell’ossessivo timore di eccedere, strabordare e oltrepassare, ecco allora un’affermazione: «Tutto oltre il punto, / è la forma esausta dello scarto» (pp. 58), laddove il punto di sutura, diviene anche punto grammaticale, per sconfinare infine in limite, punto metaforico, assoluto. È un inno alla misura, all’asciuttezza, che forse a torto ci fa tornare alla mente un passo di Nietzsche: «Un’anima nobile non è quella capace dei voli più alti, bensì quella che si innalza poco e cade poco» (Umano, troppo umano).
Prima però avevamo fatto cenno alle variazioni tematiche dell’opera. Di capitolo in capitolo infatti c’è un allontanarsi graduale dalla carne, un decentramento, l’oscillazione dall’anabasi alla catabasi. Si veda la svolta già dalla bella Radioterapia:
«Non era il corpo fiero steso nelle profondità del letto
la bocca, aperta fino alla radice,
che pregava per un osso, una cicatrice
lunga quanto vuoi, ma basta
con questo sole nelle ossa,
con il tamoxifene spinto a forza nelle vene.
Non che vedermi soffrire porti il sottile piacere
del raschio sul legno ma guarda questo affondo nella carne,
le dure masse agli incroci del collo che con ferocia
frantumano i meravigliosi ricordi.
Passerò l’anestetico sui tagli – dicevi –
e il tempo chiuderà questo cielo di vene,
di bocche troppo aperte, di crepe. Ma poi,
il rumore della sveglia è un vortice
che riempie gli angoli del cervello – vedi?
Il giorno è sempre cavo al suo interno
quasi che fossimo solo questo rumore di tubi
fissati al sedimento e gli aghi, i sedativi,
un principio di ammassamento, di comunione,
di libero accoglimento.
Perché siamo questo rischio, amore
di vespe incastrate tra le lamiere.
Siamo il buio quando si spegne».
Le tensioni corporee di prima si fanno man mano pensieri, astrazioni. Sembra che la voce narrante non abbia più davanti a sé i corpi tumefatti, straziati, e che, non dimentico, sia infine a essi sopravvissuto.
Dagli accenti leopardiani del componimento IX, dove si constatava con pacatezza l’indifferenza del cosmo e l’impero del nulla, si arriva a fine opera dove cosmo e sorti umane si riuniscono in un binomio commovente: «Si allarga. La chiglia deflagra, il midollo tocca terra. / La trachea è la pietra lucida dei tetti. / La gola che sprofonda, il vento che recide le finestre. / Urla: “Tagliatemi!” E le costellazioni si alzano in piedi» (pp. 81).
«“È la morte!” – gridano – “è il dolore!” E lei, nella sua ossessione, inventa l’illusione di essere la mancanza e che questo perdere, questo cadere senza tregua, questa totale impotenza, sia ancora, terribilmente, amore» (pp. 82). Se la carne non è più oggetto delle violenze, non è più sottoposta ai supplizi, diviene allora uno stato, participio, cicatrice di un’azione che è passata. Ritornano allora invecchiati di qualche pagina i versi: «Devi guardare la cicatrice / formarsi con fatica» (pp. 60). Il tempo, la pazienza, il dolore, l’assimilazione. Guardare una cicatrice formarsi è assistere all’inconfutabile testimonianza che qualcosa è stato, il segno inequivocabile del passaggio di qualcosa che è reale. Ma una cicatrice che si forma è soprattutto una ferita che si rimargina, è vivere un percorso di guarigione attraverso la testimonianza continua del dolore.
Il percorso del libro sembra allora venirci incontro. Ricordavamo come sin dal primo componimento troneggiasse il corpo, il suo ammasso fluttuante e senza scampo. Ora, giunti all’ultima pagina dell’ultimo capitolo, si intravede forse l’uscita, pallida, soffusa. E resta solo una parola di commiato: è la «luce», per un istante sovrana.
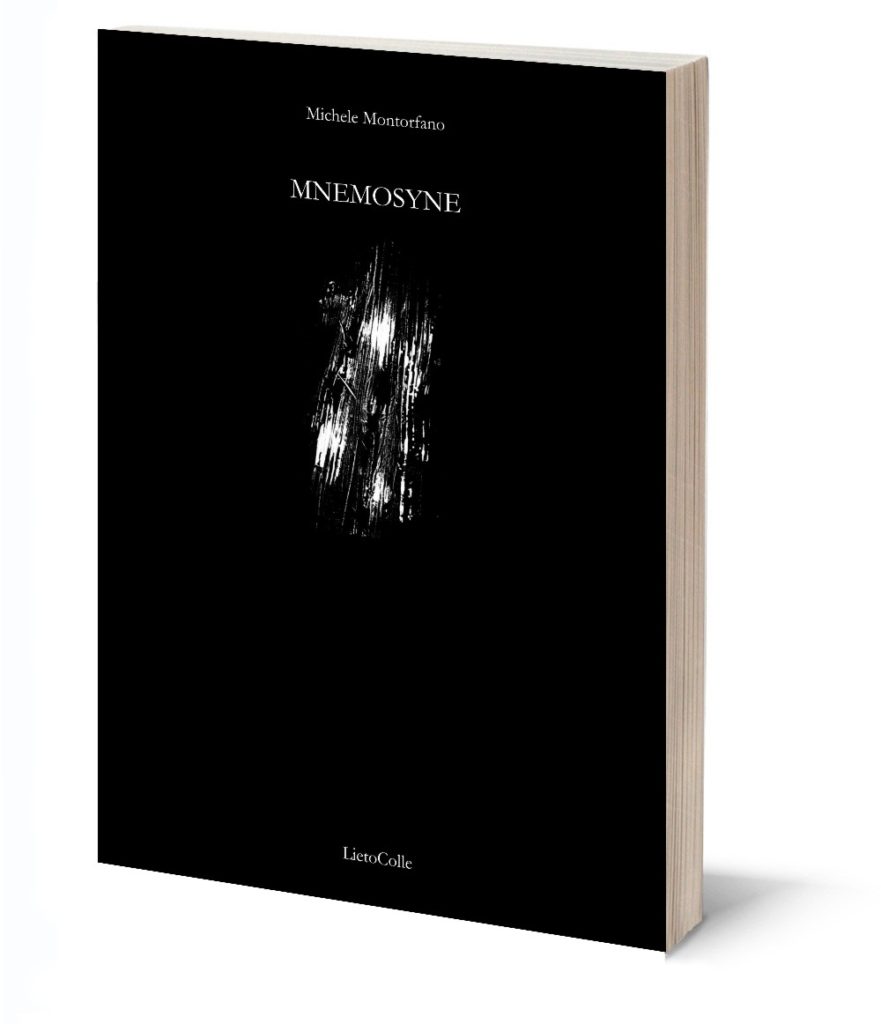
Mnemosyne di Michele Montorfano | Lieto Colle | 2014.



