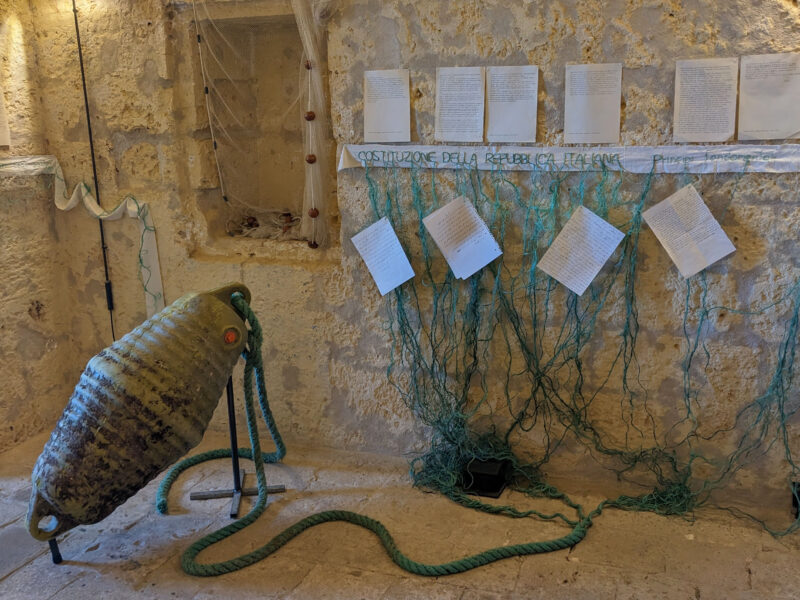Montorfano | L’Empire des lumières
Di questo quadro esistono numerose versioni che differiscono per piccoli particolari: l’aggiunta di uno specchio d’acqua antistante l’abitazione, un cielo più denso, discordante, colori ora più tenui ora più marcati. L’opera raccolse un successo immediato alla presentazione del 1954 sia per la critica sia per il pubblico. Due sono le caratteristiche che lo rendono avvincente: la netta divisione tra il giorno e la notte e l’esecuzione formale, nitida, che accentua il paradosso della compresenza degli opposti. Sconcerto e turbamento sono gli aggettivi comunemente usati per descriverlo. Ma potremmo aggiungere lo stupore, nel vedere simultaneamente il chiaro e l’oscuro del mondo; l’orrore, perché questa doppia presenza segue le regole del “totalmente estraneo” e, infine, lo spavento perché l’estraneo sembra così possibile da accadere e travolgerci. Eppure, una musica leggera pare rendere dolce la minaccia del nero e cruda la bellezza luminescente del cielo. Qualcosa di ancora sconosciuto mescola gli opposti rendendoli atipici, separati. Due opposti in fuga che si rincorrono.
Sono due diversità che convivono nella stabilità dei contrari, non si liquidano. Rimangono nella contesa perenne. La philìa deve mitigare l’odio e l’odio deve stare in quella contrarietà. Sì, due mondi sono davanti a noi. Decisi, divisi, seducenti. Ognuno nel proprio impero. Nel sotto, nello spazio in cui noi camminiamo, il buio concentra una loquacità strana, ambigua. Non è il nero denso e immobile della disperazione, ma qualcosa che si nasconde, occhieggia intorno alla luce a gas, muove l’enigma delle ombre. È un nero che gioca con i fantasmi, con l’albero immenso eppure svanente, un nero che elimina la spaventosa durezza della casa per poi tuffarsi tra le proprie spoglie, ammassandosi oltre l’ingresso sulla sinistra e costruendo un cumulo monumentale. È un nero che sta al margine, perché solo al margine è possibile trovare le parole che articolano un sapere, solo al margine le cose possono unirsi nella lotta fra il pensiero come mancanza e l’impossibilità di sopportare questa mancanza.
Poi i nostri occhi si spostano a destra, controllano se anche in quel lato ci sia stato impedito l’accesso e ancora rimangono sorpresi dal gioco della notte. Oltre il muro, oltre il cancello, l’ansia di dominio fa tacere le voci di quelli che non sono più. Se la penombra permette una visione, subito il nero la sequestra regalandoci l’abisso del non-potere, la paura dell’ostaggio, ossia di chi non è né morto né vivo, di chi è sospeso. Il lampione nel mezzo rimane debolmente acceso. Potremmo dire: resiste, ma presto capiamo che questa resistenza è un gioco utile a far danzare l’impenetrabile, a movimentarne l’ampiezza, a far emergere il desiderio dell’enigma come bellezza che salverà il mondo. L’enigma del nero che nasconde la propria bellezza, che rende misterioso il presente, perché rende tutto presente, e più la bellezza si nasconde, più va verso se stessa, verso la propria sparizione. Questa notte vuole mantenere la dismisura dell’indecisione.
Poi qualcosa cerca di liberarsi da questa morsa oscura. Da questo gioco nel quale le regole non sono conosciute e cambiano in continuazione. Qualcuno vive nella casa, si oppone al nero che muove i suoi passi fino a toccare i muri della villa. Nulla si vede all’interno. Non ci sono tende alle finestre, niente vela l’interno con l’esterno. Tutto è vuoto.
Le luci accese presto diventano solo la fascinazione e la leggerezza che trasformano la passione nella freddezza di una notte di pietra. Il gioco della notte incalza e falsa le carte. La luce artificiale del lampione che poco prima sembrava l’unica isola nelle acque remote della notte ora si afferma nella sua totale irrealtà. Due ombre speculari, impossibili, si allungano sulla facciata. Destra e sinistra del palo disegnano sulla facciata un ingresso che il nero marchia, rivelando un’inusuale gentilezza o meglio, un candore. Ombre nelle ombre, l’oscurità accarezza sovvertendo le regole della luce. E il lampione diventa il sigillo della notte: un’inviolabile riserva di solitudine.
In alto, la chiarezza impera. Le nuvole che sembrano ostacolare l’azzurro sono interi paesaggi che la luce acconsente a far esistere. Un cielo romantico come un difetto eccezionale a cui affidare i nostri sogni amorosi. Eppure è un cielo immobile. La luce che lo attraversa sembra intatta, innocente e la cima dell’albero che lo raggiunge, apponendovi il proprio nero, ora muove l’incontro con qualcosa di spaventoso, lo scontro con l’inumano, la pratica dell’impossibilità, letteralmente il tragico. Anche le nuvole sembrano variare di segno, e da territori inesplorati si aprono fino a voler coprire tutto il cielo. Da una forma acconsentita ora si mobilitano a macchia, a minaccia. Tutto è perfetto eppure è inguardabile. La certezze, invece di restare nel proprio cielo inaccessibile, discendono per costringerci senza convincerci. Notiamo allora come tutto, pur rimanendo immobile, si accavalli, muti posizione e significato, insegua l’opposto per sbranarlo, per raccoglierlo, per baciarlo. Tutto si alterna attraverso una lingua che lancia nella chiarezza di una veduta l’illeggibilità di una firma. La luce rischiara e annega. Il nero è neve candida e disperazione. Questo quadro è un’impossibilità, un’incertezza, eppure vige una stupefacente incapacità di intaccarle. Come se i pensieri, a volte, pensassero segretamente. E uno sforzo invisibile cercasse di tenersi sempre in vantaggio nella virtù dei segreti.
RENÉ MAGRITTE | L’Empire des lumières, 1953-54 | Olio su tela | 195,4 x 131,2 cm | Collezione Peggy Guggenheim, Venezia (Fondazione Solomon R. Guggenheim, New York)