
Talarico | Leggendo Ruotolo
Scrivere dalle macerie: Leggendo Corpo di pane di Elisa Ruotolo
«Scrivo dalle macerie» (pp. 34). Un solo verso può riassumere questo libro, con limpida programmaticità. Non ci girerò attorno: Corpo di pane di Elisa Ruotolo (nottetempo, 2019) è un’opera di altissimo livello.
Il volume si articola in due sezioni, rispettivamente denominate Posologia del dolore e Posologia dell’amore. Queste due sezioni tuttavia non suddividono, non spaccano il testo, ma fungono piuttosto da cardine, articolazione, punto di snodo. Questa è una terra di mezzo, dove le sfumature non sono nette: come foce salmastra, né dolce, né salata. Non è data una prescrizione medica al dolore che non contenga tracce dell’amore, non si ha un dosaggio esatto per l’amore, in cui non sia contemplato anche un pizzico di dolore. Yin e Yang sono un tutt’uno, nel Taoismo come nella medicina tradizionale cinese. È in questo punto limite che Corpo di pane si muove, è questa porzione di spazio che va ad occupare, a conferirgli i lineamenti di una scrittura di confine.
Per comprendere il titolo bisognerà forse invece adottare il codice cristiano. Stando al Sermone 235 di Sant’Agostino, il gesto eucaristico non serve a Cristo per essere visto dai discepoli, in quanto in verità era apparso loro, eppure «era visibile e insieme nascosto»; l’atto di spezzare il pane occorre lui per essere identificato nonostante fosse già stato visto: in altre parole quel gesto serve a Gesù per essere riconosciuto. Ma questa carta d’identità della Ruotolo, questo codice fiscale autentico, basilare e fragrante, più che rivelazione, più che dono è strazio, carniere per rapaci. Il suo impasto di acqua, lieviti e farine ha nervature, ematomi, fasci tesi e antenne sensibili al dolore, con una crosta friabile e sottile al posto dell’epidermide. È come se l’autrice, nell’atto di darsi un volto, si lacerasse e si esponesse alla frattura.
Ma non bisogna fraintendere l’archetipo con la religiosità. Sebbene sia questo il metro qui scelto per sciogliere i nodi di queste pagine, e sebbene nell’opera alcuni versi oscillino liberamente tra religioni e filosofie – orientali quanto occidentali -, non si può certo affermare che quello di Elisa Ruotolo sia un testo religioso. Anzi, quello dell’autrice è un laicismo che, nominandolo, non nega Dio, ma in un certo senso ci deve fare conti, relegandolo comunque sempre a una distanza dove il dialogo è inarrivabile, in una vacua marginalità che non teme di sfociare in una critica dalle tinte talvolta quasi sarcastiche.
Corpo di pane, salvo alcune eccezioni, presenta una poesia mediamente lunga, ma comunque scevra di ninnoli. L’io poetante è quasi sempre manifesto, dichiarato. La prima persona singolare offre un varco oltre la soglia della scrittrice, in un monologo talmente intimo, che di fronte a questa nudità si può avvertire un’attrazione magnetica mista al disagio, all’imbarazzo di non sapere se continuare o meno a sbirciare fra le pieghe di una confessione. Ma più che una scrittura autobiografica, di fatti e di esperienze, ci viene presentata un’autobiografia del sentire. Al lettore non si mostra un intellettuale con le sue strutture, ma un essere umano. Bisognerà però evitare l’inciampo di credere questa nudità come un qualcosa di già conquistato. Paradossalmente infatti, è proprio per questa nudità che, criticamente parlando, è un libro così difficile da spogliare.
«Non lo nego
ho avuto anch’io una vita
ho avuto la vostra vita
– ma è stata anche diversa.
Ho avuto febbri e pesti e colera
senza che nessuno ne prendesse nota.
Senza che mi venisse dato
presidio dei luoghi su cui poggiavo i miei pesi.
Senza che mi si scansasse. Così sono stata tra voi
– con voi.
Ho mangiato alla vostra tavola e bevuto dai vostri bicchieri.
Vi ho contagiato
e mandato a morte ogni giorno.
Ma questo nessuno lo ha capito
e mi avete amato – amato
come innocente creatura.
In compenso, avevo le ossa rotte dai capitomboli ogni scalino mi ha incrinato un arto
spezzato una costola
un femore.
Ogni dislivello di terra ha mancato le mie suole con misericordiosa cattiveria.
Non ho avuto gessi pesanti da portare.
Le fratture a farmi gracile come un coccio riparato non le ha viste nessuno – e mi hanno creduto solida – salda.
Hanno pensato che niente m’avrebbe atterrata o tagliato le carni
che nessun amore mi avrebbe trovata o fatta patire
– o partire.
Che non avessi sesso
né lo desiderassi a notte fonda.
Ho avuto i nervi lenti dei vecchi
e le voglie senza riparo dei bambini
i contrattempi dei faccendieri
e gli infortuni irreversibili degli atleti.
Ogni sosta forzata
ogni coma
ogni arresto di vita
ha fermato la mia.
Ma voi non lo avete saputo.
Mi avete vista in movimento
sempre tesa verso un centro
a cui non avevo mai giurato mira.
Mi avete accarezzata
quando meritavo percosse
e amata
invece di – comodamente – capire.
Avete scelto il difficile
di non vedere le mie incrinature
per potermi amare come fossi sana
mai malata appestata mai spezzata
come invece sono
in febbre in peste in pezzi.
Perdonate la mia verità capace di simulazione.
Perdonate i miei denti offesi dal tempo.
Perdonate le mie protesi ben nascoste sotto infiniti mantelli.
E i pace–maker che mi tengono in vita senza che io ne abbia diritto
e anche voglia.
Sono terremotata, io lesionata alle fondamenta.
Non venite ad abitarmi
– no
non datemi il peso delle vostre voci e dei vostri gemiti fino a tardi.
Non appendete quadri alle mie pareti non seminate bulbi nella mia terra.
Io non so proteggere
né allestire primavere
anche se ogni giorno proteggo
e improvviso belle stagioni.
Vi ho amato
l’ho fatto tutte le volte che ho mentito.
Mentivo per questo
perché pesa essere compresi.
Mi assolveva ogni gatto sdraiato lungo il ciglio
ogni laccio stretto a cavare la vena
o la vita
ogni referto di malattia
perché sotto il sole tutto era mio.
È vero
ho avuto una vita che somiglia alla vostra
ma più misera
più amante delle virgole
attenta ai perché delle gocce stillanti da un rubinetto più che al pentolino che bolle
e deborda il mio pasto.
Non mi crede nessuno:
che più pago il mio debito
e più s’aggrava» (pp. 13-14-15-16).
E ancora:
«Ho un cuore da fornaio – tutto infarinato d’un bianco
che sporca ma non dà purezza
solo pane.
Eppure a volte sento al costato come il battere secco d’un calzolaio – che lavora la suola giorno e notte
pur d’avere intorno piedi meno scalzi.
Certo, s’adatterebbe a me anche un muscolo da contadino
– resistente al sole, alle piogge, alle tregue del bene
e alle pendenze ingrate della terra
io – che ho così poca pratica di smottamenti.
Confesso però che mi attirerebbe anche un cuore da fattore
che sappia chinarsi e sporcarsi nello sgravo dell’animale femmina. O all’occorrenza il battito di quello stesso animale che geme
per la vita che gli nasce dove meno dovrebbe
– nei luoghi della lordura quotidiana.
Ma devo accontentarmi di questo acino d’uva di questo chicco di niente sfuggito alla semina di questa moneta fuori corso che non basta
a comprare nulla tantomeno un cuore nuovo
– oggi che il mio s’è fermato
nel primo pomeriggio.
So che niente si decide in cielo
o in terra – eppure massaggio il mio petto fermo come il fattore il ventre della giovenca.
Partorirò un cuore nuovo anch’io
mi scenderà tra le gambe con un dolore inutile e io non saprò che farmene» (pp. 17-18).
Più che nei componimenti brevi, è proprio nella poesia lunga e discorsiva, in questa versificazione prepotentemente orizzontale, – quasi fosse suolo su cui poggiare i piedi per poi inciampare -, che l’autrice trova la propria dimensione più incisiva, più riuscita e coinvolgente. Qui, alla maniera di una valanga, è come se il discorso acquisisse energia nel suo dispiegarsi e nel suo franare. L’autrice, fra riflessioni vorticose e mai pacificate, nel quotidiano esistenzialismo di un animale in cerca di perché («ogni giorno provo ad accomodarmi un senso» (pp. 19)), trova lieve conforto solo nel pensiero che «non resterà nulla di mio al mondo» (pp. 20). Ma Elisa Ruotolo non vuole compassione e non la chiede, sa come i «santi veri / (…) / che la carità – quaggiù / non esiste» (pp. 12) e così, pur mostrando tutte le ferite, i lembi di pelle scoperti, fugge quasi sempre con abilità l’autocommiserazione (pp. 23-24):
«Facciamo silenzio ora che il barile è al fondo e le parole sanno di legno e ruggine.
Questo non è piú tempo di bambini
la morte segna le porte una ad una
– qui sono passata – dice – e anche qui allora nulla serve
nemmeno che i cancelli stiano nei catenacci o che i fucili aspettino
col colpo a scaldare la canna. Chi mi cerca, mi troverà
a chi mi chiede io dovrò dare e a chi bussa aprire.
Sono povera e nulla posso dire mio
non queste scarpe violate dalla fanghiglia
non questi panni del mercoledì e della domenica non questo ventre che mai fu geloso del suo rosso e volle versarlo
a pigione del suo stare al mondo.
Pago con la mia ombra senza propaggini
e la castità di cibi sani
questo sonno di buona origine.
So di non aver figliato tragedie
e d’aver pagato con puntualità
al mio padrone di casa.
Gli presi a dozzina questa camera a tramontana – Vostro Onore
da allora non ho connivenze col mondo, di questo strazio
io – in verità – non ho colpe.
Domandate pure in giro
calate nei vicoli dove si mormora
ma nessun nato alzerà la mano a pretendermi madre per me in questo luogo
non esistono creature.
Eppure non sarà risparmiata questa innocenza perché l’accusa domanda giustizia.
– Non perdonatela! – dice. – Non assolvete!
E voi ubbidite: perché io so
ho sempre saputo quel che facevo.»
Se San Francesco diceva «Ricorda che quando lascerai questa terra, non potrai portare con te nulla di quello che hai ricevuto, ma solo ciò che hai dato», la Ruotolo, nel suo nichilismo, risponde con questo sillogismo: «Non ho nulla. / E sono ciò che possiedo» (pp. 25). Ma se agli estremi della propria ricerca di annullamento arriva a dichiarare di non essere mai nata (pp. 32), quest’affermazione risulta solo superficialmente accostabile a un dictat della filosofia Advaita Vedanta. In queste pagine, infatti, al contrario, tutto è dualità. Ecco allora che all’apertura, alla propria nudità donata, l’autrice, riconoscendo che «non c’è nulla che si possa dare senza pericolo» (pp. 26), reagisce con distacco, spavento e l’aggressività di un animale braccato, rivendicando la propria non appartenenza a nessuno (pp. 26).
Messe le cose in chiaro, il libro può pure proseguire:
«Ho pietà
ne ho così tanta da poterne morire.
Fa male ogni filo d’erba che sale dalla terra
fa male il buio quando strazia la luce
ma anche il chiaro che lo insidia.
Il duro del mondo è il dettaglio di metri
che abito, è l’argine che non doma il fiume
ma lo arrabbia, è il sentiero carrabile
che mangia le scarpe e va fuori paese.
Se pure pregassi i grani non verrebbero alle dita il male non sgualcirebbe né cadrebbe in briciole se pure accorressi ai porti o ai monti
si finirebbe ai fondali o si cadrebbe in valanga,
comunque. (…)» (pp. 38)
Oltre che dall’autocommiserazione, l’autrice, al termine di questi versi intrisi di un panteismo del dolore, arriva a metterci nuovamente in guardia e ad avere persino «pena di questa pietà» (pp. 38). Ma Corpo del pane non conosce solo il gesto violento e mortifero, lo scarto e la spellatura. La sua ricchezza è nell’incontro che sa instaurare fra questi e una delicatezza di prim’ordine. A un registro capace di immagini quali l’«esecuzione del nascere» (pp. 33), che nel suo bagliore lascia poco spazio a qualsiasi commento, sa anche accostare «questa carne che trema / e balbetta alla vita» (pp. 41), senza cadere nella tentazione di non riconoscere, in questa carne, per quanto carne, l’innata e sensibile fragilità del vivere. D’altro canto, questa scrittura febbrile così attenta ai suoni duri delle consonanti, è in grado di captare, centellinare e incastonare parole più morbide, quasi a dettare il respiro del suono che colma queste pagine. E a proposito di questa capacità di uno sguardo e di una musicalità non unilaterali, la metafora antropocentrica, forte e al contempo lieve di pp. 56 potrebbe esserne un ulteriore esempio:
«Il mio corpo era chiuso
era un corpo da noce–infanta.
Poi il contadino arrivò con la sua lunga pertica scosse il ramo mio e io caddi
sulla terra che chiamava.
A quel punto mi cercò tra le altre noci
ero uguale alle altre, io
appena più ossuta
lo strappo violento mi aveva
reciso il braccio con cui mi tenevo al legno
e scuoiato un po’ di pelle
– eppure ero ancora noce.
Potevo resistere per giorni
contro il sole che mi voleva
asciutta, ma il contadino mi prese
e mi svestì macchiandosi le dita nel verde cruento del mio mallo.
Pensavo si sarebbe fermato contro il guscio ma sbriciolò anche quello
sotto il peso della suola.
Ora mi mangerà
– pensai fosse un’ora bellissima
per essere mangiata –
i rami presi dalla violenza
e la pioggia di noci a cadere
a cadere.
Invece mi lasciò dov’ero
– piccola infanta senza gusto
senza succo né carne di noce vera.
E allora sentii la terra chiamare più forte».
All’interno di questa opera troveremo pochi, pochissimi riferimenti al nostro quotidiano. È come se ci trovassimo, – entro i limiti di un linguaggio fresco – di fronte a un libro pensato per essere astorico, quindi adatto per ogni tempo. Quest’autobiografia interiore non concede fatti, e tanto meno riferimenti geografici, né coordinate temporali. Le sue immagini, i suoi oggetti sono quasi sempre rigorosamente non Hi-Tech, o, per meglio dire, quasi sempre non strettamente contemporanei.
L’amore qui cantato è un amore crudo, spigoloso, che guasta e che rovina (pp. 66), ma anche un istinto impossibile da seppellire, un atto involontario come il cieco battere e ribattere di un cuore, che nel bramare dimentica (pp. 67) e nel ferirsi, pericolosamente manca ancora l’occasione di spezzarsi (pp. 74). Forse l’autrice a tratti vorrebbe dire con Antonin Artaud «et l’amour? Il faut nous laver / de cette crasse héréditaire», ma molto probabilmente e semplicemente, non è questa la sua natura:
«Chiedo che passi tutto: il male e l’amore ogni compromissione tentata e negata con la vita.
Insegnami la gioia del niente
la lingua oscura della terra che parla dal grano
fammi essere antica come il fuoco vulnerabile come il legno
e senza anima.
Aiutami a tenere a casa la stanchezza a restare nascosta nei desideri
e nella fame.
In fine proteggi a lungo questa verità – come l’orcio colmo quando hai sete – che è violento e smisurato
l’amore dei timidi» (pp. 76).
È solo una delle non infrequenti chiose tranchant di queste pagine. Ma ci offre uno spunto ulteriore. Se dapprincipio ci accostavamo all’intimità dell’autrice con attrazione mista a disagio, ecco che a monito ci vengono affidate queste ultime parole (da una persona che sicuramente l’umanità un poco l’ha capita). I suoi versi che si offrono senza veli, meritano di essere letti senza veli. Vanno guardati negli occhi, vanno sfogliati con rispetto e mano ferma. Questa carneficina non è data per voyeur, né per dita palpitanti di chi a stento ne regge lo sguardo. Se vuoi comprendere questa nudità, devi essere nudo.
Nel presente scenario che si consuma e mai si acquieta, dopo Artaud si potrebbero tirare facilmente in ballo I canti di Maldoror di Lautréamont, o Gottfried Benn, o ancora pensatori lucidi, destrutturanti e corrosivi come Emil Cioran o il poeta Ilarie Voronca (in particolare quello di Emorragia, ascesa). Ma, cosa oggi quantomai rara, ci troviamo di fronte a una poesia forte di una cifra distinguibilissima e di una identità netta e riconoscibile. È questo il pane eucaristico di Elisa Ruotolo.
La tensione non allenta fino alla fine. Per chi cercasse un momento di distensione, è bene che sappia che qui non c’è spazio per le pause. Al termine di questi versi aperti e scavati come incisioni, ustionati dal vivere e dallo scontro con l’altro, anche questo libro può essere riposto. Questo libro che tra le mani ancora brucia, questo libro che non sa richiudersi se non nella misura di uno schianto (pp. 37).
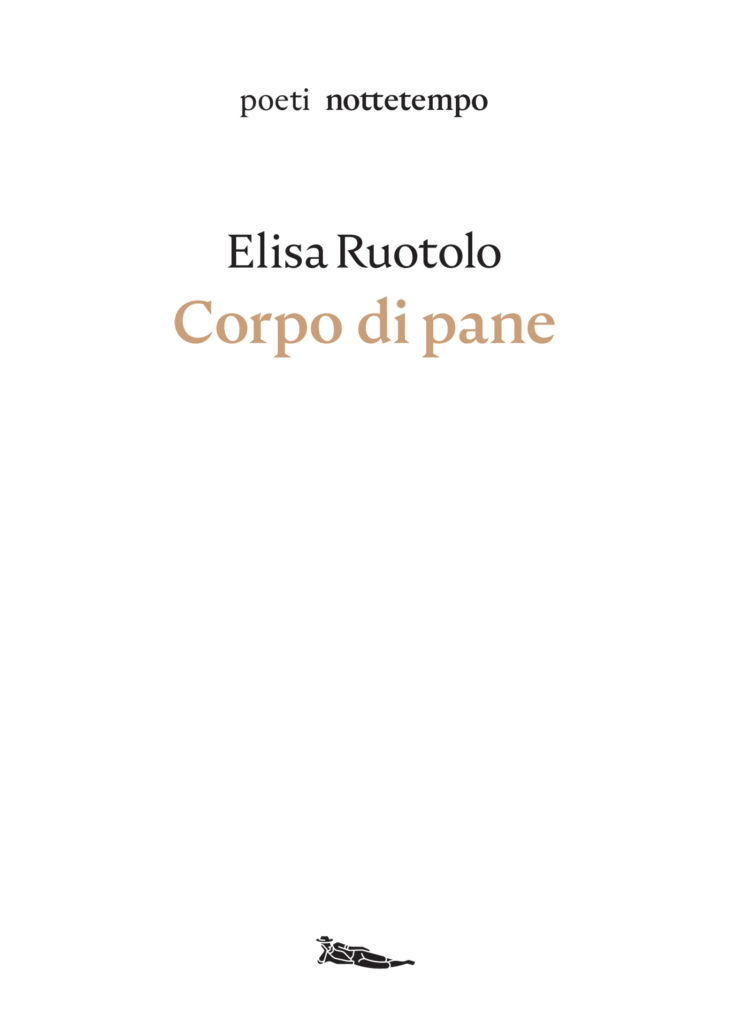
Corpo di pane di Elisa Ruotolo | nottetempo | 2019.




Gabriella Grasso
Uno sguardo profondo e sensibile che coglie molto da vicino la verità di Corpo di pane, secondo la mia percezione di lettrice